8 Gennaio
La nostra lingua è in pericolo
Giordano Bruno Guerri contro il massacro quotidiano dell'italiano ha lanciato su Twitter il torneo #salviamoneuna. Ridare vita alle parole in via di estinzione. Su List racconta la sua rivolta in difesa della lingua italiana. La follia dei concorsi in inglese.
di Giordano Bruno Guerri
C’è un crudele ma benefico gioco della torre, su Twitter. Fra queste #paroleinviadiestinzione, quale scegliereste di salvare? #addietro #glabro #aulico #voluttà #gnatologo #resilienza #gratologo #giubba #magnetofono #basito. Ha vinto voluttà, e la bellezza della parola mi consola per la sconfitta della mia prediletta, glabro: “Accoglimi nelle tue ascelle glabre.” Non capisco invece cosa c’entri “resilienza”, parola ignota ai più e diventata di moda per sostenere qualunque sciocchezza. C’è da sperare che faccia una brutta fine. L’idea di salvare le #paroleinviadiestinzione nacque quando il mio secondogenio (neologismo) Pietro, sei anni, accarezzandomi le gote disse: “Perché ti fai crescere la barba. Ti accarezzerei meglio senza peli, babbo.” Senza peli? Orrore: glabro, figlio mio, glabro. Oggi Pietro possiede una parola in più, un’arma acuminata in più rispetto ai suoi coetanei – e maggiori – verbosi quanto poveri di lingua. Del genio di Nanni Moretti rimarranno l’attesa dell’alba a occidente, la passeggiata in Vespa, la danza guardando in tv Silvana Mangano e lo schiaffo alla giornalista che parla come un giornale stampato: “Le parole sono importanti!”, e giù un ceffone. “Ma lei è fuori di testa!”, ribatte la percossa, e giù un altro ceffone, più forte: “Ma come parlaaaaaa!!!”

Fra le gioie della vita di cui – forse – resterò privo, c’è percuotere qualcuno per come parla. È una triste, civile, rinuncia. Che cerco di compensare gettando ogni tanto un salvagente alla nostra mamma non ancora diventata mamy, la Lingua Italiana. Il torneo #salviamoneuna è appena iniziato, ma dà già buoni frutti. Ne abbiamo selezionate 400, io e una misteriosa @Crilu42 che mi assiste giocosamente e caritatevolmente. Ogni giorno ne vengono elencate 10, fra cui votarne una. Il voto deve avvenire inserendo la parola in una frase, come “La tua #voluttà m’incanta”. Le vincitrici passeranno a una sfida successiva, fra...
di Giordano Bruno Guerri
C’è un crudele ma benefico gioco della torre, su Twitter. Fra queste #paroleinviadiestinzione, quale scegliereste di salvare? #addietro #glabro #aulico #voluttà #gnatologo #resilienza #gratologo #giubba #magnetofono #basito. Ha vinto voluttà, e la bellezza della parola mi consola per la sconfitta della mia prediletta, glabro: “Accoglimi nelle tue ascelle glabre.” Non capisco invece cosa c’entri “resilienza”, parola ignota ai più e diventata di moda per sostenere qualunque sciocchezza. C’è da sperare che faccia una brutta fine. L’idea di salvare le #paroleinviadiestinzione nacque quando il mio secondogenio (neologismo) Pietro, sei anni, accarezzandomi le gote disse: “Perché ti fai crescere la barba. Ti accarezzerei meglio senza peli, babbo.” Senza peli? Orrore: glabro, figlio mio, glabro. Oggi Pietro possiede una parola in più, un’arma acuminata in più rispetto ai suoi coetanei – e maggiori – verbosi quanto poveri di lingua. Del genio di Nanni Moretti rimarranno l’attesa dell’alba a occidente, la passeggiata in Vespa, la danza guardando in tv Silvana Mangano e lo schiaffo alla giornalista che parla come un giornale stampato: “Le parole sono importanti!”, e giù un ceffone. “Ma lei è fuori di testa!”, ribatte la percossa, e giù un altro ceffone, più forte: “Ma come parlaaaaaa!!!”

Fra le gioie della vita di cui – forse – resterò privo, c’è percuotere qualcuno per come parla. È una triste, civile, rinuncia. Che cerco di compensare gettando ogni tanto un salvagente alla nostra mamma non ancora diventata mamy, la Lingua Italiana. Il torneo #salviamoneuna è appena iniziato, ma dà già buoni frutti. Ne abbiamo selezionate 400, io e una misteriosa @Crilu42 che mi assiste giocosamente e caritatevolmente. Ogni giorno ne vengono elencate 10, fra cui votarne una. Il voto deve avvenire inserendo la parola in una frase, come “La tua #voluttà m’incanta”. Le vincitrici passeranno a una sfida successiva, fra loro, fino a individuarne una che deve indubbiamente venire resuscitata nell’uso comune.
Il torneo #salviamoneuna è appena iniziato, ma dà già buoni frutti. Ne abbiamo selezionate 400.
Ieri, nella seconda giornata, c’è stata una dura tenzone fra #abiura #infingardo #cinematografo #pleonasmo #beccheria #gnomone #scellerato #tonitruante #graveolente #ammennicolo. Ha vinto infingardo, e me rallegro assai, perché è una meravigliosa, opulenta parola crudelmente schiacciata fra “pigro” e “indolente”, delle quali ha in più l’accenno a una inoperosità furbetta e volontaria, di scelta tattica: ecco, per esempio, il voto di Titti Consalvi, @ttsdpin: “Galileo Galilei: un geniale #pleonasmo tra #scellerata #abiura e #infingarda censura.” Al terzo turno sono in gara #aporia #preconizzare #vezzoso #malandrino #imbrunire #leggiadro #pleonastico #fellone #asciolvere #belluino. Voterò belluino, che merita la salvezza almeno dalla confusione cui è avvinta con beduino, di cui si crede sia un comportamento, mentre attiene alle belve.
Giochi e raffinatezze a parte, la nostra lingua è in grave pericolo. E non tanto perché è poco diffusa. Anzi, possiamo rallegrarci che secondo le statistiche sia la più studiata all’estero, dopo le lingue “utili”: inglese, spagnolo, cinese. Battiamo dunque francese, giapponese, russo, tedesco, ma non per merito di noi viventi: grazie ai pittori, ai musicisti, ai poeti del passato che hanno reso indispensabile conoscere l’italiano per fare certe cose o per gustare a fondo certe bellezze.
Noi viventi, l’italiano lo stiamo massacrando. Non parlo soltanto, badate, dell’invasione degli anglicismi: non più invasione, ma accoglienza entusiasta, come si accolgono i liberatori. La commistione è normale - anzi salutare, come fra gli umani - finché sta in limiti fisiologici. Nessuno più oserebbe discutere su bar (che fra l’altro viene da barra) o su sport. Ma feedback non ci ha liberato dalla schiavitù del riscontro, ci ha sottoposto a un provincialismo appunto da sottomissione: mai rispondere altro - a chi ti chiede un feedback - che fuck you.
Cedere sull’anglosuperfluo significa poi cedere anche sulla stessa struttura della lingua. Avete notato che quasi tutte le lettere, anche le mail, cominciano con un “sono a chiedere, siamo a proporre”? Siamo chi? Sono che? E giù una manata forte, dai Nanni, dagliela, che io non posso. Poi spiega loro che stanno passivamente, inutilmente, erroneamente traducendo I’m. Cioè pensano in inglese senza sapere l’inglese, perché non può conoscere bene una lingua straniera chi non conosce bene la propria. E qui arriviamo al punto davvero dolente.
Feedback non ci ha liberato dalla schiavitù del riscontro, ci ha sottoposto a un provincialismo appunto da sottomissione: mai rispondere altro - a chi ti chiede un feedback - che fuck you.
Un popolo è tale non perché riunito negli stessi confini, sotto le stesse leggi e le stesse tasse, che attengono allo Stato. Un popolo è tale perché ha la stessa lingua e la stessa storia. (Fino a pochi decenni fa ci si metteva anche la stessa religione, oggi ne facciamo a meno.) A difendere la storia ci pensano – più o meno bene – gli storici, e comunque non la si può cambiare, la si può interpretare, più o meno bene. Per la lingua è diverso: se tu, Stato, imponi film italiani in televisione, e in quei film si parla un cattivo italiano, difenderai la produzione italiana, non la cultura e la lingua italiana.
Ma era solo un altro esempio. La vergogna nazionale è venuta da una recentissima deliberazione del MIUR, altrimenti detto Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Il 27 dicembre il MIUR ha reso pubblico l’atteso bando per il finanziamento dei progetti universitari di interesse nazionale, imponendo che la domanda debba essere compilata esclusivamente in lingua inglese. Il professor Claudio Marazzini, presidente dell’Accademia della Crusca, ha subito definito la decisione “una follia”. E’ vero, Spagna, Francia, Germania, non farebbero mai scelte di questo tipo. Difendendo la propria lingua i popoli difendono se stessi o – come si banalizza oggi – la propria “identità”. E se in molte discipline scientifiche conoscere l’inglese è quasi indispensabile, è ancora più vero che per i progetti umanistici (non parliamo neppure di quelli linguistici) il ricorso a una lingua straniera appare demenziale. Tanto che nel 2012 venne richiesta una domanda compilata sia in italiano sia inglese, e nel 2015 si lasciò la libertà di adottare l’inglese o l’italiano. “Abolire l’italiano in una domanda rivolta alla pubblica amministrazione è autolesionista e suicida”, ha concluso il saggio e attonito professor Marazzini.
Il 27 dicembre il MIUR ha reso pubblico l’atteso bando per il finanziamento dei progetti universitari di interesse nazionale, imponendo che la domanda debba essere compilata esclusivamente in lingua inglese.
(Oh, non tentate di giocarmi il tiro del retrogrado, rincattucciato nel paesello. I miei figli sono già perfettamente bilingui, e il primogenio a undici anni traduce abbastanza bene - dicono i voti - dall’inglese al cinese.)
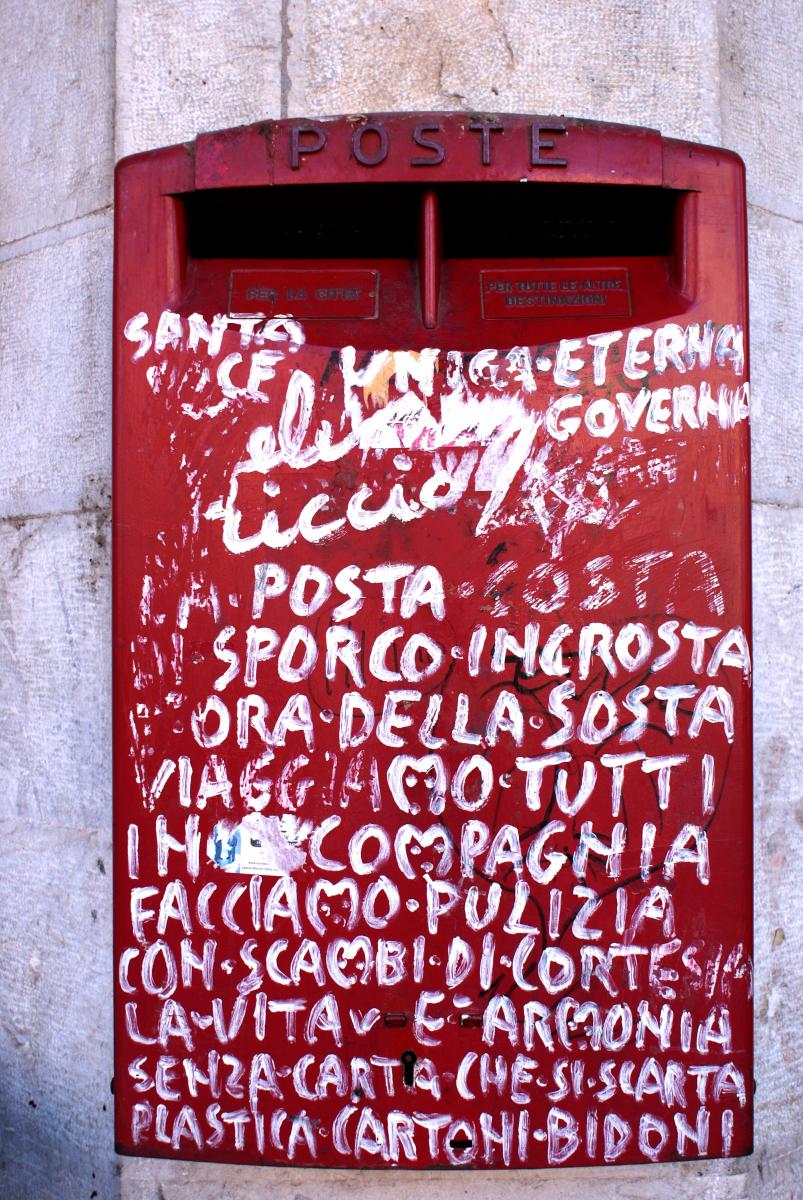
Il fatto è che conoscere e usare bene una lingua straniera non deve mai significare la rinuncia alla propria, vero ministro (o ministra, se preferisce) Fedeli (Gentile ministro/a Fedeli, mi preme chiarire subito che non polemizzerò con lei per la sua laurea mancata, importa assai che lei sia laureata, anzi, quando aboliamo finalmente il valore legale del titolo di studio? Né infierirò sugli errori grammaticali o di sintassi che le vengono attribuiti, possono capitare, specialmente dell’eloquio e addirittura nella scrittura frettolosa. Né, tantomeno, farò dell’ironia sulla sua capigliatura, che trovo bella, suggestiva, fantasiosa, tanto che vorrei sentirla sul mio petto glabro, accarezzarla con dolcezza di amico.)
No. Ce l’ho con lei per la risposta che ha dato al professor Marazzini. Lei sostiene che, “a scelta del proponente, la domanda può essere fornita anche una ulteriore versione in lingua italiana”, sottintendendo che si tratta di un vezzo superfluo. Poi definisce la questione della lingua “non rilevantissima”. Infine deve “ricordare che le lingue si definiscono per quelli che sono anche i loro spettri d’impiego. E l’inglese è, semplicemente, la lingua veicolare della comunicazione internazionale fra ricercatrici e ricercatori”. Moretti, dove sei? Salì a bordo, CAZZO!
Certo, “avremo bisogno di migliaia di valutatori attinti anche a banche-dati estere”: immagino che non siano tanti gli italiani in grado di valutare un progetto in inglese. Ma il punto di vero dolore – politico, prima che culturale - è che l’italiano muore, se si accetta così arrendevolmente e a priori che non possa essere la lingua della ricerca: proprio perché nella ricerca prevale l’inglese.
L’italiano muore, se si accetta così arrendevolmente e a priori che non possa essere la lingua della ricerca: proprio perché nella ricerca prevale l’inglese.
È inutile, poi, se non risibile, che lei si compiaccia di iniziative come i test invalsi, durante i quali i docenti aiutano gli studenti, per non fare brutta figura loro, e dunque insegnano a barare; e che nella “Buona Scuola” (sic) sia stato introdotto un tema “linguistico-creativo” dedicato “alla conoscenza e alla pratica della scrittura creativa, della poesia e di altre forme simili di espressione, della lingua italiana, delle sue radici classiche, dei linguaggi e dei dialetti parlati in Italia”. MORETTI!!!
Ministro/a, lei lo sa che moltissimi nostri insegnanti, come moltissimi nostri concittadini, non sono in grado di parlare un buon italiano? Non ho detto scrivere, ho detto parlare. Vuole realizzare una immensa – benefica, storica – riforma, se fra qualche mese le capiterà ancora la ventura di essere ministro/a del MIUR? Introduca in tutte le scuole di ogni ordine e grado l’insegnamento della pronuncia italiana. Che dovrà essere un corso di dizione - primario e obbligatorio, indispensabile per accedere alla cattedra - nelle facoltà che producono docenti: solo così otterremo che i nostri ragazzi, anche quelli che parlano benissimo inglese, che vanno alla conquista del mondo, abbiano su di sé per sempre il bollo della loro provincia di origine.
Ministro Fedeli, introduca in tutte le scuole di ogni ordine e grado l’insegnamento della pronuncia italiana.
Accade che - anche fra chi scrive bene, è colto, legge - la pronuncia dell’italiano faccia a dire poco difetto. Per esempio, due quinti degli italiani pronunciano bosco, stringendo orribilmente la bocca a culo di gallina sulla “o”, altri due terzi la dilatano come se riemergessero da un’apnea secolare, biesplodendo in bosco. Lo stesso per la “e”, in migliaia di parola fra le più comuni, con milioni di persone incapaci di distinguere fra la pesca che sta sugli alberi e quella che si fa nelle acque, con moltiplicazioni miracolose di doppie, con pestilenze micidiali di altre doppie. Ho sentito con le mie orecchie un professore universitario di biologia parlare per ore di topi, e ancora mi chiedo di quali esotici e misteriosi animali si tratti. Se non per l’italiano, lo faccia per l’inglese, ministro/a: ho ragione di credere che quel docente parli allo stesso modo nella lingua di Shakespeare: anche se è al top della ricerca.
Intanto si diverta con noi. Le parole di domani sono #ameno #atavico #uggioso #quid #baciamano #bislacco #desueto #incanutire #ostia #soliloquio #uscio e – senza allusioni - #scriteriato.
Iscriviti per leggere l'articolo completo.
30 giorni gratis per te
Ti manca poco per entrare nel Club. Completa la registrazione
Ti abbiamo mandato una mail su . Per completare la registrazione, apri la mail che ti abbiamo mandato e fai clic sul link di conferma. Grazie!
INFORMATIVA PRIVACY RELATIVA AL SERVIZIO NEWSLIST
Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice privacy”), dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679 del 2016 (il “Regolamento privacy”), del Provvedimento n. 229 del 2014 del Garante della Protezione dei Dati Personali (rubricato “Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l'uso dei cookie”), nonché della Raccomandazione n. 2 del 2001 adottata ai sensi dell’art. 29 della Direttiva n. 95/46/CE, List S.r.l. intende informare gli Utenti in merito all’utilizzo dei loro dati personali, dei log files e dei cookie raccolti tramite la navigazione nel Sito www.newslist.it (di seguito, il “Sito”).
- Titolare, Responsabili del trattamento dei dati e Responsabile della Protezione dei Dati
Il titolare del trattamento dei dati personali è List S.r.l. (di seguito, il “Titolare” o “List”), con sede legale Roma (00196), Via Ferdinando di Savoia n. 3, partita IVA 14403801005, email help@newslist.it.
L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento, ove designati, può essere fornito su richiesta da parte degli Utenti.
Nel caso in cui venga nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (ai sensi dell’art. 37 del Regolamento privacy), i dati identificativi dello stesso saranno resi noti mediante pubblicazione dei medesimi, integrando la presente informativa.
Il titolare del trattamento dei dati personali relativi al Sito è Legalitax Studio Legale e Tributario, con sede in Roma (00196), Via Flaminia n. 135.
- Categorie, natura e finalità dei dati trattati
List tratterà alcuni dati personali degli Utenti che navigano e interagiscono con i servizi web del Sito.
- Dati di navigazione
Si tratta di dati di navigazione che i sistemi informatici acquisiscono automaticamente durante l’utilizzo del Sito, quale l’indirizzo IP, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier), nonché i dettagli delle richieste inviate al server del Sito, e che ne rendono possibile la navigazione. I dati di navigazione potranno altresì essere utilizzati per compilare statistiche anonime che permettono di comprendere l’utilizzo del Sito e di migliorare la struttura dello stesso.
Infine, i dati di navigazione potranno eventualmente essere utilizzati per l’accertamento di attività illecite, come in casi di reati informatici, a danno del Sito.
- Dati forniti dall’Utente
L’eventuale invio di comunicazioni ai contatti indicati sul Sito comporta l’acquisizione dell’indirizzo e-mail e degli ulteriori dati personali contenuti nella comunicazione, previo rilasci di idonea informativa.
- Cookie
- Siti web di terze parti
I siti di terze parti a cui è possibile accedere tramite questo Sito non sono coperti dalla presente Privacy policy. Gli stessi potrebbero utilizzare cookie differenti e/o adottare una propria Privacy policy diversa da quella di questo Sito, relativamente ai quali quest’ultimo non risponde. Consigliamo pertanto di consultare di volta in volta la relativa informativa sull’utilizzo dei cookie e seguire le istruzioni per la disabilitazione degli stessi, qualora lo si desiderasse.
- Natura del conferimento dei dati
Fermo restando quanto indicato in relazione ai dati di navigazione e ai cookie, gli Utenti sono liberi di fornire i propri dati personali, ove richiesti nelle apposite sezioni del Sito; il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ricevere la fornitura dei servizi da loro richiesti.
- Modalità del trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, e per il periodo di tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Le informazioni raccolte sono registrate in un ambiente sicuro.
- Ambito di comunicazione dei dati
I dati personali degli Utenti saranno trattati dal personale incaricato di List. Inoltre, i loro dati personali potranno essere trattati da terzi, fornitori di servizi esterni, che agiscano per conto o a nome di List, debitamente nominati quali Responsabili del trattamento, e che tratteranno i dati in conformità allo scopo per cui i dati sono stati in origine raccolti.
- Diffusione dei dati
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
- Diritti dell’interessato
Il Codice privacy e il Regolamento privacy conferiscono agli Utenti l’esercizio di specifici diritti.
Gli Utenti in qualsiasi momento potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice privacy e s.m.i. e di cui agli art. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento privacy, inviando una comunicazione scritta ai recapiti del Titolare di cui al precedente paragrafo 1 e, per l’effetto, ottenere:
- la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali degli Utenti con indicazione della relativa origine, verificarne l’esattezza o richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione;
- l’accesso, la rettifica, la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento;
- la cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali trattati in violazione di legge.
Gli Utenti, inoltre, potranno opporsi al trattamento dei dati personali che li riguardano.
- Aggiornamenti
La Privacy policy del Sito potrà essere soggetta a periodici aggiornamenti.
Termini e condizioni di vendita dei servizi di abbonamento
I presenti termini d'uso disciplinano la fornitura digitale del servizio in abbonamento (di seguito,
il"Servizio" o
l'"Abbonamento") a List nelle diverse formule di volta in volta disponibili. Il Servizio è fornito da List
S.r.l., con
sede in Via Ferdinando di Savoia, 3 - 00196 Roma P. IVA 14403801005, iscritta al registro delle imprese di
Roma, numero
di iscrizione RM/1518421 (di seguito, il "Fornitore").
Il Servizio è rivolto esclusivamente a utenti maggiorenni. (di seguito, l'"Utente" o gli "Utenti").
List è il servizio digitale che fornisce agli Utenti contenuti editoriali, giornalistici e informativi di
qualità;
maggiori informazioni su List sono disponibili navigando sul sito internet https://newslist.it/ (di seguito,
il "Sito").
Il Servizio è disponibile in abbonamento via web a partire dal Sito, nonché attraverso l'applicazione List
(di seguito,
l'"Applicazione") per dispositivi mobili con sistema operativo IOS 11.0 o successivi e Android 6.0 o
successivi.
Il costo dei dispositivi, delle apparecchiature e della connessione internet necessari per la fruizione del
Servizio non
è ricompreso nel Servizio e si intende a carico dell'Utente.
1. Caratteristiche del Servizio
1.1 Il Servizio ha ad oggetto la fruizione in abbonamento dei contenuti editoriali della testata List.
L'Abbonamento è
disponibile esclusivamente in formato digitale; resta quindi espressamente esclusa dal Servizio la fornitura
dei
contenuti in formato cartaceo.
1.2 Il Servizio è a pagamento e comporta il pagamento di un corrispettivo a carico dell'Utente (con le
modalità previste
nel successivo articolo 5).
1.3 L'Utente può scegliere tra diverse formule a pagamento per la fruizione del Servizio; il costo, la
durata, le
modalità di erogazione e gli specifici contenuti di ciascun pacchetto sono specificati nella pagina di
offerta
pubblicata su https://newslist.it/fe/#!/register ovvero all'interno dell'Applicazione. Il contenuto
dell'offerta deve
intendersi parte integrante dei presenti termini d'uso e del connesso contratto tra il Fornitore e l'Utente.
2. Acquisto dell'abbonamento
2.1 Ai fini dell'acquisto di un Abbonamento è necessario (i) aprire un account List; (ii) selezionare un
pacchetto tra
quelli disponibili; (iii) seguire la procedura di acquisto all'interno del Sito o dell'Applicazione,
confermando la
volontà di acquistare l'Abbonamento mediante l'apposito tasto virtuale. L'Abbonamento si intende acquistato
al momento
della conferma della volontà di acquisto da parte dell'Utente; a tal fine, l'Utente accetta che faranno fede
le
risultanze dei sistemi informatici del Fornitore. La conferma vale come espressa accettazione dei presenti
termini
d'uso.
2.2 L'Utente riceverà per email la conferma dell'attivazione del Servizio, con il riepilogo delle condizioni
essenziali
applicabili e il link ai termini d'uso e alla privacy policy del Fornitore; è onere dell'Utente scaricare e
conservare
su supporto durevole il testo dei termini d'uso e della privacy policy.
2.3 Una volta confermato l'acquisto, l'intero costo dell'Abbonamento, così come specificato nel pacchetto
acquistato,
sarà addebitato anticipatamente sullo strumento di pagamento indicato dall'Utente.
2.4 Effettuando la richiesta di acquisto dell'Abbonamento, l'Utente acconsente a che quest'ultimo venga
attivato
immediatamente senza aspettare il decorso del periodo di recesso previsto al successivo articolo 4.
2.5 Per effetto dell'acquisto, l'Utente avrà diritto a fruire del Servizio per l'intera durata
dell'abbonamento;
l'Utente, tuttavia, non può sospendere per alcun motivo la fruizione del Servizio durante il periodo di
validità
dell'Abbonamento.
3. DURATA, DISDETTA E RINNOVO DELL'ABBONAMENTO
3.1 L'Abbonamento avrà la durata di volta in volta indicata nel pacchetto scelto dall'Utente (per esempio,
mensile o
annuale).
3.2 L'Abbonamento si rinnoverà ciclicamente e in modo automatico per una durata eguale a quella
originariamente scelta
dall'Utente, sino a quando una delle Parti non comunichi all'altra la disdetta dell'Abbonamento almeno 24
ore prima del
momento della scadenza. In mancanza di disdetta nel termine indicato, l'Abbonamento è automaticamente
rinnovato.
3.3 L'Utente potrà esercitare la disdetta in ogni momento e senza costi attraverso una delle seguenti
modalità:
seguendo la procedura per la gestione dell'Abbonamento all'interno del proprio profilo utente sia sul Sito
che
nell'Applicazione;
inviando una mail al seguente indirizzo: help@newslist.it.
3.4 Gli effetti della disdetta si verificano automaticamente alla scadenza del periodo di abbonamento in
corso; fino a
quel momento, l'Utente ha diritto a continuare a fruire del proprio Abbonamento. La disdetta non dà invece
diritto ad
alcun rimborso per eventuali periodi non goduti per scelta dell'Utente.
3.5 In caso di mancato esercizio della disdetta, il rinnovo avverrà al medesimo costo della transazione
iniziale, salvo
che il Fornitore non comunichi all'Utente la variazione del prezzo dell'Abbonamento con un preavviso di
almeno 30 giorni
rispetto alla data di scadenza. Se, dopo aver ricevuto la comunicazione della variazione del prezzo,
l'Utente non
esercita la disdetta entro 24 ore dalla scadenza, l'Abbonamento si rinnova al nuovo prezzo comunicato dal
Fornitore.
3.6 Il Fornitore addebiterà anticipatamente l'intero prezzo dell'Abbonamento subito dopo ogni rinnovo sullo
stesso
strumento di pagamento in precedenza utilizzato dall'Utente ovvero sul diverso strumento indicato
dall'Utente attraverso
l'area riservata del proprio account personale.
4. Recesso DEL CONSUMATORE
4.1 L'Utente, ove qualificabile come consumatore – per consumatore si intende una persona fisica che agisce
per scopi
estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, ha
diritto di
recedere dal contratto, senza costi e senza l'onere di indicarne i motivi, entro 14 giorni dalla data di
attivazione
dell'Abbonamento acquistato.
4.2 L'Utente può comunicare la propria volontà di recedere, inviando al Fornitore una comunicazione
esplicita in questo
senso mediante una delle seguenti modalità:
mediante raccomandata a.r. indirizzata alla sede del Fornitore;
per email al seguente indirizzo help@newslist.it;
4.3 Ai fini dell'esercizio del recesso l'Utente può, a sua scelta, utilizzare questo modulo
4.4 Il termine per l'esercizio del recesso si intende rispettato se la comunicazione relativa all'esercizio
del diritto
di recesso è inviata dall'Utente prima della scadenza del periodo di recesso.
4.5 In caso di valido esercizio del recesso, il Fornitore rimborserà all'Utente il pagamento ricevuto in
relazione
all'Abbonamento cui il recesso si riferisce, al netto di un importo proporzionale a quanto è stato fornito
dal Fornitore
fino al momento in cui il consumatore lo ha informato dell'esercizio del diritto di recesso; per il calcolo
di tale
importo, si terrà conto dei numeri o comunque dei contenuti fruiti e/o fruibili dal consumatore fino
all'esercizio del
diritto di recesso. Il rimborso avverrà entro 14 giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso sullo
stesso
mezzo di pagamento utilizzato per la transazione iniziale.
4.6 Eventuali eccezioni al diritto di recesso, ove previste da Codice del consumo – decreto legislativo 6
settembre
2005, n. 206, saranno comunicate al consumatore in sede di offerta prima dell'acquisto.
5. Modalità di pagamento
5.1 L'Abbonamento comporta l'obbligo per l'Utente di corrispondere al Fornitore il corrispettivo nella
misura
specificata nell'offerta in relazione al pacchetto scelto dall'Utente.
5.2 Tutti i prezzi indicati nell'offerta si intendono comprensivi di IVA.
5.3 Il pagamento dei corrispettivi può essere effettuato mediante carte di credito o debito abilitate ad
effettuare gli
acquisti online. Le carte accettate sono le seguenti: Visa, Mastercard, American Express.
5.4 L'Utente autorizza il Fornitore ad effettuare l'addebito dei corrispettivi dovuti al momento
dell'acquisto
dell'Abbonamento e dei successivi rinnovi sulla carta di pagamento indicata dallo stesso Utente.
5.5 Il Fornitore non entra in possesso dei dati della carta di pagamento utilizzata dall'Utente. Tali dati
sono
conservati in modo sicuro dal provider dei servizi di pagamento utilizzato dal Fornitore (Stripe o il
diverso provider
che in futuro potrà essere indicato all'Utente). Inoltre, a garanzia dell'Utente, tutte le informazioni
sensibili della
transazione vengono criptate mediante la tecnologia SSL – Secure Sockets Layer.
5.6 È onere dell'Utente: (i) inserire tutti i dati necessari per il corretto funzionamento dello strumento
di pagamento
prescelto; (ii) mantenere aggiornate le informazioni di pagamento in vista dei successivi rinnovi (per
esempio,
aggiornando i dati della propria carta di pagamento scaduta in vista del pagamento dei successivi rinnovi
contrattuali).
Qualora per qualsiasi motivo il pagamento non andasse a buon fine, il Fornitore si riserva di sospendere
immediatamente
l'Abbonamento fino al buon fine dell'operazione di pagamento; trascorsi inutilmente 3 giorni senza che il
pagamento
abbia avuto esito positivo, è facoltà del Fornitore recedere dal contratto con effetti immediati.
Pagamenti all'interno dell'applicazione IOS
5.7 In caso di acquisto dell'Abbonamento mediante l'Applicazione per dispositivi IOS, il pagamento è gestito
interamente
attraverso la piattaforma App Store fornita dal gruppo Apple. Il pagamento del corrispettivo è
automaticamente
addebitato sull'Apple ID account dell'Utente al momento della conferma dell'acquisto. Gli abbonamenti
proposti sono
soggetti al rinnovo automatico e all'addebito periodico del corrispettivo. L'Utente può disattivare
l'abbonamento fino a
24h prima della scadenza del periodo di abbonamento in corso. In caso di mancata disattivazione,
l'abbonamento si
rinnova per un eguale periodo e all'Utente viene addebitato lo stesso importo sul suo account Apple.
L'Utente può
gestire e disattivare il proprio abbonamento direttamente dal proprio profilo su App Store. Per maggiori
informazioni al
riguardo: https://www.apple.com/it/legal/terms/site.html. Il Fornitore non è responsabile per eventuali
disservizi della
piattaforma App Store.
6. Promozioni
6.1 Il Fornitore può a sua discrezione offrire agli Utenti delle promozioni sotto forma di sconti o periodi
gratuiti di
fruizione del Servizio.
6.2 Salvo che non sia diversamente specificato nella pagina di offerta della promozione, l'adesione a una
promozione
comporta, alla sua scadenza, l'attivazione automatica del Servizio a pagamento con addebito periodico del
corrispettivo
in base al contenuto del pacchetto di volta in volta selezionato dall'Utente.
6.3 L'Utente ha la facoltà di disattivare il Servizio in qualunque momento prima della scadenza del periodo
di prova
attraverso una delle modalità indicate nel precedente articolo 3).
7. Obblighi e garanzie dell'Utente
7.1 L'Utente dichiara e garantisce:
- di essere maggiorenne;
- di sottoscrivere l'Abbonamento per scopi estranei ad attività professionali, imprenditoriali, artigianali
o commerciali
eventualmente svolte;
- che tutti i dati forniti per l'attivazione dell'Abbonamento sono corretti e veritieri;
- che i dati forniti saranno mantenuti aggiornati per l'intera durata dell'Abbonamento.
7.2 L'Utente si impegna al pagamento del corrispettivo in favore del Fornitore nella misura e con le
modalità definite
nei precedenti articoli.
7.3 L'Utente si impegna ad utilizzare l'Abbonamento e i suoi contenuti a titolo esclusivamente personale, in
forma non
collettiva e senza scopo di lucro; l'Utente è inoltre responsabile per qualsiasi uso non autorizzato
dell'Abbonamento e
dei suoi contenuti, ove riconducibile all'account dell'Utente medesimo; per questo motivo l'Utente si
impegna ad
assumere tutte le precauzioni necessarie per mantenere riservato l'accesso all'Abbonamento attraverso il
proprio account
(per esempio, mantenendo riservate le credenziali di accesso ovvero segnalando senza ritardo al Fornitore
che la
riservatezza di tali credenziali risulta compromessa per qualsiasi motivo).
7.4 La violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo conferisce al Fornitore il diritto di
risolvere
immediatamente il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, fatto salvo il risarcimento dei
danni.
8. Tutela della proprietà intellettuale e industriale
8.1 L'Utente riconosce e accetta che i contenuti dell'Abbonamento, sotto forma di testi, immagini,
fotografie, grafiche,
disegni, contenuti audio e video, animazioni, marchi, loghi e altri segni distintivi, sono coperti da
copyright e dagli
altri diritti di proprietà intellettuale e industriale di volta in volta facenti capo al Fornitore e ai suoi
danti causa
e per questo si impegna a rispettare tali diritti.
8.2 Tutti i diritti sono riservati in capo ai titolari; l'Utente accetta che l'unico diritto acquisito con
il contratto
è quello di fruire dei contenuti dell'Abbonamento con le modalità e i limiti propri del Servizio. Fatte
salve le
operazioni di archiviazione e condivisione consentite dalle apposite funzionalità del Servizio, qualsiasi
attività di
riproduzione, pubblica esecuzione, comunicazione a terzi, messa a disposizione, diffusione, modifica ed
elaborazione dei
contenuti è espressamente vietata.
8.3 La violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo conferisce al Fornitore il diritto di
risolvere
immediatamente il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, fatto salvo il risarcimento dei
danni.
9. Manleva
9.1 L'Utente si impegna a manlevare e tenere indenne il Fornitore contro qualsiasi costo – inclusi gli
onorari degli
avvocati, spesa o danno addebitato al Fornitore o in cui il Fornitore dovesse comunque incorrere in
conseguenza di usi
impropri del Servizio da parte dell'Utente o per la violazione da parte di quest'ultimo di obblighi
derivanti dalla
legge ovvero dai presenti termini d'uso.
10. Limitazione di responsabilità
10.1 Il Fornitore è impegnato a fornire un Servizio con contenuti professionali e di alta qualità; tuttavia,
il
Fornitore non garantisce all'Utente che i contenuti siano sempre privi di errori o imprecisioni; per tale
motivo,
l'Utente è l'unico responsabile dell'uso dei contenuti e delle informazioni veicolate attraverso di
essi.
10.2 L'Utente riconosce e accetta che, data la natura del Servizio e come da prassi nel settore dei servizi
della
società dell'informazione, il Fornitore potrà effettuare interventi periodici sui propri sistemi per
garantire o
migliorare l'efficienza e la sicurezza del Servizio; tali interventi potrebbero comportare il rallentamento
o
l'interruzione del Servizio. Il Fornitore si impegna a contenere i periodi di interruzione o rallentamento
nel minore
tempo possibile e nelle fasce orarie in cui generalmente vi è minore disagio per gli Utenti. Ove
l'interruzione del
Servizio si protragga per oltre 24 ore, l'Utente avrà diritto a un'estensione dell'Abbonamento per un numero
di giorni
pari a quello dell'interruzione; in tali casi, l'Utente riconosce che l'estensione dell'Abbonamento è
l'unico rimedio in
suo favore, con la conseguente rinunzia a far valere qualsivoglia altra pretesa nei confronti del
Fornitore.
10.3 L'Utente riconosce e accetta che nessuna responsabilità è imputabile al Fornitore:
- per disservizi dell'Abbonamento derivanti da malfunzionamenti di reti elettriche e telefoniche ovvero di
ulteriori
servizi gestiti da terze parti che esulano del tutto dalla sfera di controllo e responsabilità del Fornitore
(per
esempio, disservizi della banca dell'Utente, etc...);
- per la mancata pubblicazione di contenuti editoriali che derivi da cause di forza maggiore.
10.4 In tutti gli altri casi, l'Utente riconosce che la responsabilità del Fornitore in forza del contratto
è limitata
alle sole ipotesi di dolo o colpa grave.
10.5 Ai fini dell'accertamento di eventuali disservizi, l'Utente accetta che faranno fede le risultanze dei
sistemi
informatici del Fornitore.
11. Modifica dei termini d'uso
11.1 L'Abbonamento è disciplinato dai termini d'uso approvati al momento dell'acquisto.
11.2 Durante il periodo di validità del contratto, il Fornitore si riserva di modificare i termini della
fornitura per
giustificati motivi connessi alla necessità di adeguarsi a modifiche normative o obblighi di legge, alle
mutate
condizioni del mercato di riferimento ovvero all'attuazione di piani aziendali con ricadute sull'offerta dei
contenuti.
11.3 I nuovi termini d'uso saranno comunicati all'Utente con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla
scadenza del
periodo di fatturazione in corso ed entreranno in vigore a partire dall'inizio del periodo di fatturazione
successivo.
Se l'Utente non è d'accordo con i nuovi termini d'uso, può esercitare la disdetta secondo quanto previsto al
precedente
articolo 3.
11.4 Ove la modifica dei termini d'uso sia connessa alla necessità di adeguarsi a un obbligo di legge, i
nuovi termini
d'uso potranno entrare in vigore immediatamente al momento della comunicazione; resta inteso che, solo in
tale ipotesi,
l'Utente potrà recedere dal contratto entro i successivi 30 giorni, con il conseguente diritto ad ottenere
un rimborso
proporzionale al periodo di abbonamento non goduto.
12. Trattamento dei dati personali
12.1 In conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679 UE e dal Codice della privacy (decreto
legislativo 30
giugno 2003, n. 196), i dati personali degli Utenti saranno trattati per le finalità e in forza delle basi
giuridiche
indicate nella privacy policy messa a disposizione dell'Utente in sede di registrazione e acquisto.
12.2 Accettando i presenti termini di utilizzo, l'Utente conferma di aver preso visione della privacy policy
messa a
disposizione dal Fornitore e di averne conservato copia su supporto durevole.
12.3 Il Fornitore si riserva di modificare in qualsiasi momento la propria privacy policy nel rispetto dei
diritti degli
Utenti, dandone notizia a questi ultimi con mezzi adeguati e proporzionati allo scopo.
13. Servizio clienti
13.1 Per informazioni sul Servizio e per qualsiasi problematica connessa con la fruizione dello stesso,
l'Utente può
contattare il Fornitore attraverso i seguenti recapiti: help@newslist.it
14. Legge applicabile e foro competente
14.1 Il contratto tra il Fornitore e l'Utente è regolato dal diritto italiano.
14.2 Ove l'Utente sia qualificabile come consumatore, per le controversie comunque connesse con la
formazione,
esecuzione, interpretazione e cessazione del contratto, sarà competente il giudice del luogo di residenza o
domicilio
del consumatore, se ubicato in Italia.



