29 Ottobre
Politica. Benvenuti nel deserto delle bandiere
WeekList. Nazione, Stato, sovranità, globalizzazione, secessione e governo. Un viaggio nell'arte della politica tra tecnocrazie emergenti, disconnessioni dal vecchio mondo e allacciamenti al cavo di un nuovo mondo caotico.
Viviamo tempi difficili. Forse troppo. Il titolare di List non ha nessuna intenzione di farli apparire facili, ma con questo primo appuntamento di WeekList intende almeno provare a fissarne l'immagine e proiettarla nel domani. Sul taccuino di oggi c'è in testa la parola "politica", il principio di tutto, l'arte suprema dell'uomo ("l'uomo è un animale politico", Aristotele) e lo facciamo stando al bancone del nostro bar, miscelando long drink da sorseggiare con calma, di svariata gradazione alcolica, e immagini che evocano, velano e svelano il senso e il controsenso dell'Esistere. Gilles Gressani intervista François Bayart che fa esplodere una serie di bengala che illuminano la giungla politica, parla delle idee e delle parole che popolano il dibattito politico e lo confondono: Stato, sovranità, liberismo, globalizzazione. È un discorso controvento, dove emerge in filigrana il fenomeno del "macronismo", dove si sente il colpo di cannone della Brexit, la mietitrebbia dell'Ohio di Trump e l'ondata di referendum sulle piccole patrie, dal Kurdistan alla Catalogna. Uno spettacolo pirotecnico di guerra e pace tra Oriente e Occidente, in uno scenario dove nel racconto di Michele Magno la politica conferma il suo Essere (e non Essere) spettacolo, rappresentazione, lo scatto e lo scarto, dal reaganismo fino ai nostri giorni. In questa ondata di singoli sparsi e moltitudini riunite, la dissoluzione degli imperi precede quella degli Stati, viviamo in un'era che Lorenzo Castellani tratteggia leggendo le pagine dell'ultimo libro di Parag Khanna, "La rinascita delle città-Stato", dove la parola "rinascita" ci dice che c'è qualcosa di antico, l'eterno ritorno della Storia in altre forme, visioni, divisioni e con la crescita esponenziale della tecnologia, soprattutto connessioni. In questa rete di relazioni, in questo rapporto tra il software dell'umano e l'hardware che tende sempre più "pensante" della tecnologia, l'individuo, il singolo, scopre il contrasto interiore, il dissidio, il posto e l'opposto di un'idea, si ritrova come...
Viviamo tempi difficili. Forse troppo. Il titolare di List non ha nessuna intenzione di farli apparire facili, ma con questo primo appuntamento di WeekList intende almeno provare a fissarne l'immagine e proiettarla nel domani. Sul taccuino di oggi c'è in testa la parola "politica", il principio di tutto, l'arte suprema dell'uomo ("l'uomo è un animale politico", Aristotele) e lo facciamo stando al bancone del nostro bar, miscelando long drink da sorseggiare con calma, di svariata gradazione alcolica, e immagini che evocano, velano e svelano il senso e il controsenso dell'Esistere. Gilles Gressani intervista François Bayart che fa esplodere una serie di bengala che illuminano la giungla politica, parla delle idee e delle parole che popolano il dibattito politico e lo confondono: Stato, sovranità, liberismo, globalizzazione. È un discorso controvento, dove emerge in filigrana il fenomeno del "macronismo", dove si sente il colpo di cannone della Brexit, la mietitrebbia dell'Ohio di Trump e l'ondata di referendum sulle piccole patrie, dal Kurdistan alla Catalogna. Uno spettacolo pirotecnico di guerra e pace tra Oriente e Occidente, in uno scenario dove nel racconto di Michele Magno la politica conferma il suo Essere (e non Essere) spettacolo, rappresentazione, lo scatto e lo scarto, dal reaganismo fino ai nostri giorni. In questa ondata di singoli sparsi e moltitudini riunite, la dissoluzione degli imperi precede quella degli Stati, viviamo in un'era che Lorenzo Castellani tratteggia leggendo le pagine dell'ultimo libro di Parag Khanna, "La rinascita delle città-Stato", dove la parola "rinascita" ci dice che c'è qualcosa di antico, l'eterno ritorno della Storia in altre forme, visioni, divisioni e con la crescita esponenziale della tecnologia, soprattutto connessioni. In questa rete di relazioni, in questo rapporto tra il software dell'umano e l'hardware che tende sempre più "pensante" della tecnologia, l'individuo, il singolo, scopre il contrasto interiore, il dissidio, il posto e l'opposto di un'idea, si ritrova come Massimiliano Trovato, smarrito a Barcellona, tra indipendentisti e unionisti, piccole patrie e grandi nazioni, un liberale in mezzo al guado, tra la libertà del diritto alla secessione e il rischio della piccola gabbia separatista, così vicina al confine dell'idea della minoranza totalitaria. Tra tecnocrazie emergenti, disconnessioni dal vecchio mondo e allacciamenti al cavo di un nuovo mondo caotico, a fare ordine e bene comune dovrebbe esserci il governo, la decisione, l'azione, preceduta dall'atto della legislazione, fare buone leggi per tutti, e qui il caso italiano messo a fuoco da Vitalba Azzollini ci insegna che siamo lontanissimi dal risultato per assenza di programmazione e misurazione dell'impatto della decisione. Il bene comune, così vicino, così lontano. Siamo su un'isola in un mare di sabbia, un avamposto pieno di bandiere. Resta sul taccuino la domanda del vecchio compagno Lenin: che fare? Il titolare non intende filosofarci troppo e ha la sua risposta: beviamoci sopra. Barman, un Gin Martini. Buona lettura di WeekList.
01
Bar Politics. Barman, un cocktail nazional-liberalista
Sovranità, Stato e globalizzazione. Come tutto questo si tiene e nello stesso tempo confligge. Intervista a François Bayart: "Il nazional-liberalismo è un cocktail che ogni barman crea a modo suo".

Dove Jean-François Bayart, studioso della sociologia e della politica comparata, docente al Graduate Institute di Ginevra, tenta di dare una collocazione coerente alla rinascita dell'idea di nazione e alla inesorabile (le merci viaggeranno sempre e così pure i capitali) globalizzazione. Ricchissima di spunti d'analisi, l'intervista di Bayart fa un passaggio molto interessante sull'omologazione del modello nazional-liberale in cui il controllo dello Stato e il pendolo tra il nazionale e il liberale fanno poi la differenza. L'intervista è di Gilles Gressani, è stata pubblicata su Le Grand Continent, esce anche su List grazie alla collaborazione con il Groupe d’études géopolitiques di Parigi.
A cura di Gilles Gressani
Traduzione Sofia Scialoja
Con L’illusion identitaire del 1996, e poi, soprattutto dal 2012, lei ha affinato il concetto di nazional-liberalismo; potrebbe spiegare ai nostri lettori cosa intende con questa espressione?
Il dibattito pubblico, sia quello politico che quello mediatico – compresa l’Università, in particolare gli specialisti delle relazioni internazionali – si è chiuso in false evidenze. Ovvero, lo Stato-nazione sarebbe una vittima della globalizzazione, e l’identitarismo sarebbe una risposta dei popoli a quest’ultima. Un po’ come le ostriche che si chiudono al contatto con il limone. Secondo questo ragionamento a somma zero, la globalizzazione metterebbe in pericolo la nostra sovranità, la nostra cultura, la nostra identità. Eppure la sociologia storica e la politica comparata rivelano che lo Stato-nazione è figlio della globalizzazione; e che, da quasi due secoli, quest’ultima ha avuto come ideologia il culturalismo e le sue varie forme complementari di espressione, fra cui l’invenzione e la mercificazione della tradizione, la generalizzazione delle coscienze particolaristiche, l’orientalismo.
La sociologia storica e la politica comparata rivelano che lo Stato-nazione è figlio della globalizzazione.
Il parametro per comprendere gli ultimi due secoli è la triangolazione tra l’integrazione differenziata di un certo numero di mercati. Fra questi i mercati dei capitali, del commercio, della forza del lavoro (sebbene in misura minore), i mercati della scienza, della tecnologia, il mercato della fede tramite l’evangelizzazione del mondo, l’espansione dell’islam nel seno della colonizzazione e dello scatenamento pentecotista, l’universalizzazione dello Stato-nazione come unico modo di organizzazione politica, la diffusione dell’identitarismo sotto forma di etnicità in Africa, del confessionalismo in Libano, del comunitarismo in India, del nazionalismo etnoculturale in Europa, della definizione etno confessionale della cittadinanza un po’ dappertutto nel mondo. Soprattutto nel contesto risultante dal passaggio da un mondo di imperi ad un sistema internazionale di Stati-nazione.
Siamo chiaramente di fronte ad un pensiero egemonico che si morde la coda, riproducendosi sulla scia neoliberale; avatar contemporaneo del nazional-liberalismo, ovvero di questa triangolazione tra mercato, Stato-nazione ed identitarismo.
Questa è una tesi che sviluppo dalla pubblicazione de L’Illusion identitaire del 1996; tesi ripresa nel Gouvernement du monde, del 2004, in una serie di articoli di stampa raggruppati in Sortir du national-libéralisme? del 2012 e poi in L’Impasse national-libérale del 2017. Ciò nonostante mi stupisce, da un lato, l’incapacità –o la mancanza di volontà - da parte della stampa di munirsi appieno di questa mia delucidazione, al fine di discuterla; e, dall’altro, il fatto di essere regolarmente invitato da varie redazione in quanto “esperto” di questo o di quello. Siamo chiaramente di fronte ad un pensiero egemonico che si morde la coda, riproducendosi, impavidamente ed elettoralmente da circa quarant’anni, sulla scia del neoliberalismo; avatar contemporaneo del nazional-liberalismo, ovvero della triangolazione fra mercato, Stato-nazione ed identitarismo.
In questo senso, qual è la sua analisi rispetto al contesto politico francese?
L’epicentro francese di questa Weltanshauung nazional-liberale sarebbe la Grande Coalizione di fatto tra la destra repubblicana e la sinistra, decisamente piu liberale che sociale, che ha reso possibile la conversione del Partito socialista al neoliberalismo negli anni Ottanta, oggi incarnata da Macron; un occhio sui mercati, l’altro sulla Pulzella d’Orléans e la grandiosità monarchica. Epicentro che si trova in tensione con le due versioni più squilibrate del nazional-liberalismo: il lepenismo, all’estrema destra, e il mélenchonisme, all’estrema sinistra. Personalità come Sarkozy, Wauquiez e Valls giocano, denti stretti e petto in fuori, ai cavalleggeri tra il cuore e i confini del nazional-liberalismo.
Macron, un occhio sui mercati, l’altro sulla Pulzella d’Orléans e la grandiosità monarchica.
Ma i termini dell’equazione restano disperatamente gli stessi da un protagonista all’altro. Equazione che non costituisce una soluzione ai problemi ai quali siamo confrontati ma che, al contrario, tende ad aggravarli.
Il concetto di nazional-liberalismo può servire come prospettiva interpretativa di questa tendenza referendaria: la Spagna con la Catalogna, l’Iraq con il Kurdistan iracheno, ed anche sull’Italia con la Lombardia?
Effettivamente mi sembra che questi referendum confermino il proseguimento del processo d’universalizzazione dello Stato-nazione, fose anche prodotto in una scissione, e in modo identitarista: tramite l’invenzione di una tradizione E la creazione di un’identità nazionale - per citare rispettivamente Eric Hobsbawn e Anne-Marie Thiesse. Nella loro forma attuale, i nazionalismi catalano e curdo dovrebbero essere considerati il prodotto della fine del diciannovesimo secolo, o dell’inizio del ventesimo, e non attestarsi come un’ “essenza” nazionale plurisecolare.
Questi referendum confermano la prosecuzione del processo d’universalizzazione dello Stato-nazione, fosse anche per via di scissione.
Riferendosi a Deleuze, essi rappresentano un “evento” che è essenza di un’identità, anche se assegnata tramite referendum. Non dimentichiamoci che Erbil è una città multietnica e multiconfessionale e che un referendum, al giorno d’oggi, rappresenta una minaccia d’esplosione e di epurazione etnica. Allo stesso modo, per quel che riguarda i Catalani con i congiunti Castigliani… In questo senso, il referendum sottomette gli elettori ad una scelta identitaria binaria che distorce la loro vita e la loro esperienza sociale.
Per quanto riguarda il nazionalismo lombardo e la Padania, si tratta di un artificio piuttosto kitsch, il cui unico significato risiede nel rigetto dell’Altro (o supposto tale): ieri il Meridionale, oggi l’Immigrato. Nei casi della Catalogna e del Nord Italia, la rivendicazione stato-nazionale ed identitarista sopravviene nelle regioni più industrializzate del paese; le più ricche, le più integrate all’economia capitalista mondiale. Perciò, in questi casi, assistiamo ad un nazional-liberalismo la cui sociologia è ben diversa da quella della Brexit o dall’elettorato di Trump. D’altro canto, il caso del Kurdistan ci rimanda soprattutto al passaggio da un mondo d’imperi ad un sistema di Stati-nazione, da me menzionato ne L’Impasse national-libérale. Le circostanze storico-politiche hanno privato i “Curdi” –denominazione a mio avviso sinceramente non ben controllata - dello Stato-nazione che gli era stato promesso sulle spoglie dell’Impero ottomano.
Il caso del Kurdistan ci rimanda soprattutto al passaggio da un mondo d’imperi ad un sistema di Stati-nazione, da me menzionato ne L’Impasse national-libérale.
Al pari degli Armeni, i Curdi sono stati circondati a tenaglia da altri Stati-nazione: lo Stato turco, lo Stato iracheno, lo Stato siriano, lo Stato iraniano, dall’impero russo ricostituitosi su modello sovietico, all’indomani della Prima guerra mondiale, e dalla dislocazione dell’Impero ottomano. Tentano la loro riscossa, urtando contro le stesse difficoltà già presenti negli anni venti del Novecento. Ma a Erbil il nazionalismo curdo non ha palesemente nulla contro il mercato mondiale (il caso del PKK è molto diverso, anche se finge di aver abbandonato la sua ideologia rivoluzionaria alquanto totalitaria e nonostante la propensione occidentale a scordarsi di lui nel contesto di guerra contro Daesh).
Lei crede che si possa spiegare il recente successo del referendum in quanto mezzo per le élites “liberali” di governare i “nazionali” ? Come lei sembra suggerire in un passaggio del suo ultimo libro sullla Brexit, L’impasse natonal-libérale?
Direi piuttosto che, in questo caso, la tecnica referendaria si inscrive in continuità con la dottrina wilsoniana dell’autodeterminazione delle minoranze e con il trattato di Versailles (così come con i trattati annessi). Con i risultati che conosciamo… La Shoah, la Seconda guerra mondiale, l’epurazione etnica dei Tedeschi d’Europa centrale e balcanica, l’ingegneria demografica dello stalinismo nell’URSS e nelle democrazie popolari. Una storia dalla quale, malgrado la costruzione europea, non siamo ancora completamente distaccati; o nella quale ricadiamo a furia del persistere delle nostre radici cristiane o giudeo-cristiane.
Direi piuttosto che, in questo caso, la tecnica referendaria si iscrive in continuità alla dottrina wilsoniana dell’autodeterminazione delle minoranze ed al trattato di Versailles.
Il caso della Brexit è diverso, e costituisce un’anomalia politica della storia parlamentare del Regno Unito. È associato a un gioco delle tre carte di David Cameron, una specie di trucchetto il cui esito ha completamente colto di sorpresa la classe politica britannica. Non può essere il generale De Gaulle chiunque voglia. Quest ultimo ha fatto plebiscitare la sua scelta. David Cameron ha pensato fosse una mossa furba sottomettere a referendum una Brexit da lui non voluta. D’altronde, il referendum può essere al servizio di una concezione universalista e non identitarista della comunità, alla stregua dell’idea del “plebiscito di tutti i giorni” con cui Renan definiva la nazione (anche se degli autori come Marcel Detienne e Gérard Noiriel hanno, a giusto titolo, ricordato che non tutti erano obbligati a partecipare e che in fondo questa particolare concezione della nazione non si allontanava tanto dal nazionalismo etnicoculturale tedesco quanto si sia voluto dire o credere). D’altra parte, si dovrebbe riflettere sull’uso del referendum intrapreso da Maduro in Venezuala, uso che Mélenchon non trova affatto allarmante: molto nazionalismo, poco liberalismo…
È possibile confondere l’affetto “nazionale” con un’altra tendenza da lei descritta nel suo recente libro: l’illusione identitaria?
Certo. Il nazionalismo è sempre l’invenzione di una tradizione, e quindi di un’identità. La polis è un atto immaginario; come d’altronde quello della nazione –di cui ci ricordiamo grazie al contributo di Benedict Anderson. Fondamentalmente, l’immaginazione è costituente, come dice Paul Veyne a proposito della religione e della cosa politica. Castoriadis parlava dal canto suo dell’istituzione immaginaria della società. Si pongono allora due domande.
Qual è il rapporto col passato, che sia di rottura o di continuità, di questa istituzione immaginaria della società?
Castoriadis e Ricoeur non erano dello stesso parere su questo tema. Penso che Bergson possa portare una risposta interessante, con la sua idea della “compenetrazione delle durate”. E per quanto riguarda ciò che segue, questa finzione è utile o no? Non sono totalmente convinto dell’utilità dell’illusione nazionale, che ha, in un secolo, mandato a morte milioni di Europei e di Medio Orientali, e che ha proceduto spesso e volentieri tramite purificazione etnica, se non tramite genocidio. Il trionfo del nazional-liberalismo nella Turchia di Erdogan, il rinnovo della definizione etnoconfessionale della cittadinanza in Medio-Oriente, dall’Israele all’Irak, passando per il Libano e per la Siria, i demoni maligni che si aggirano nei Balcani; la brutalità anti-immigratoria dell’Unione europea, sempre più di competenza della Corte penale internazonale; tutti elementi che non aiutano a separarmi dai miei dubbi patriottici. A giusto titolo, ci siamo scandalizzati dei crimini del nazional-socialismo e dello stalinismo. Ma non dimentichiamoci che essi stessi erano indissociabili dall’idea nazionale. Ne L’Impasse national-libérale, ha scioccato il mio tentativo di trascrivere le terribili frasi di Victor Klemperer, pronunciate durante la Seconda guerra mondiale, che descrivevano nazismo e sionismo come due entità spalla a spalla, in piena conoscenza di causa dell’uno e dell’altro. Ma questi lettori sbigottiti –per primo, Laurent Joffrin- sembra ignorino chi fosse Victor Klemperer, le cui parole, per quanto scomode, meritano un minimo di attenzione e di riflessione relativamente alla nostra definzione di appartenenza politica.
Che visione ha rispetto alla situazione catalana e rispetto alla sua futura evoluzione?
Sinceramente nessuna, data la mia scarsa conoscenza della penisola iberica. Terrei semplicemente a mente il fatto che lo Stato assolutista spagnolo, potenzialmente nazionale, nacque dall’impero coloniale tra il sedicesimo e diciasettesimo secolo; e che la Spagna contemporanea è, costituzionalmente, uno Stato plurinazionale, un po’ come il Regno Unito. La questione catalana rimanda a quella scozzese, e non ha equivalenti in Francia o in Italia.
Nel nostro lavoro abbiamo provato varie volte a riprendere la vecchia opposizione geopolitica tra nomadi e sedentari, articolandola secondo una nuova tipologia: i nomadi virtuali (quelli che possono sempre partire senza rischiare di essere declassati) e i sedentari essenziali (quelli per cui uno spostamento è, essenzialmente, un declassamento). In questo senso, secondo lei, il nazional-liberalismo potrebbe essere letto come tentativo di organizzazione –o riorganizzazione- politica di un ordine geopoliticamente sconvolto dall’emergere relativamente recente di modi di spostamento di persone e di flussi quasi instantanei che erano normalmente trattenuti dallo Stato-nazione? La causa dell’impasse nazional-liberale potrebbe dunque rinvenirsi nell’assenza di una configurazione geopolitica adeguata a questa recente accellerazione?
Non mi sono mai fidato di questo genere di opposizioni binarie che, all’occorrenza, accordano troppa importanza all’idea di virtualità, a mio avviso abbastanza abusata, lasciando altri fenomeni nell’ombra. Per esempio, avendo lavorato molto sull’Africa, ho constatato che l’instaurazione di un ordine nazional-liberale tende a constringere alla sedentarietà gli Africani storicamente avidi di mobilità. In particolare i nomadi (reali), che vengono territorializzati. Inoltre, lo spostamento viene vissuto dai migranti come un’opportunità, una consacrazione sociale. Ciò ovviamente non impedisce ad altri tipi di spostamentI di essere dei declassamenti, o, peggio, in caso di guerra, delle repressioni crudeli o delle espulsioni. D’altro canto, il concetto di nazional-liberalismo non si riferisce solamente al periodo più contemporaneo, ma rende più compresibile quest effetto di triangolazione tra integrazione mondiale, universalizzazione dello Stato-nazione e generalizzazione dell’identarismo, fenomeni osservabili sin dal diciannovesimo secolo.
L’instaurazione di un ordine nazional-liberale tende a constringere alla sedentarietà gli Africani, storicamente avidi di mobilità: in particolare i nomadi (reali), territorializzandoli.
Per quanto riguarda l’effetto di “accelerazione”, è un concetto totalmente relativo. I nostri antenati l’hanno sperimentato con il battello a vapore, il telegrafo, il telefono, l’aereo. Malgrado debba ricorrere ad un binomio, ripeterò che il nazional-liberalismo, è liberalismo per i ricchi e nazionalismo per i poveri. Oggi, così come nel diciannovesimo secolo. Detto ciò, la formula è troppo polemica, per non apparire troppo facile. La contribuzione della sociologia storica e la politica comparata, alla quale mi associo, è reticente a tutta forma di ragionamento binario o lineare.
Non ci sono differenze qualitative tra il nazional-liberalismo di Orban, Marine Le Pen o Macron, e quello di Xi, Putin o Trump. Questi ultimi sembrano infatti disporre di una capacità effettiva nel trattenere, al meno in parte, i flussi (gli oligarchi russi possono essere considerati, da un lato, parte del nomadismo grazie alle loro possibilità economiche; e, dall’altro, sedentari, dato il loro legame con Putin – possono vivere a Londra o a Courmayeur; ma saranno sempre soggetti a sanzioni). In pratica, possiamo parlare anche di un neonazional-liberalismo?
Il nazional-liberalismo è una tipologia ideale che non corrisponde mai alla realtà di una società concreta. Si tratta di un concetto. Inoltre, questo idealtipo può diventare intellegibile esclusivamente alla luce della storicità propria alle società che consideriamo.
Il nazional-liberalismo è un cocktail che ogni barman crea a modo suo.
Le questioni in gioco non sono le stesse, per quanto riguarda i vari casi, in particolare in materia di libertà pubbliche. Utilizzerò la metafora del barman. Il nazional-liberalismo è un cocktail che ogni barman crea a modo suo. Alcuni forzeranno la mano sul liberale, altri sul nazionale. Ma nessuno potrà fare a meno dell’uno o dell’altro ingrediente; a meno che non si inventi un altro cocktail. La differenza qualitativa tra queste diverse combinazioni del cocktail nazional-liberale, è il loro carattere letale. Xi e Putin sembrano capaci di controllo. Ma non dimentichiamoci della repressione, molto nazional-liberale, dell’immigrazione messa in atto dalla nostra virtuosa Europa che ogni anno fa più morti di Boko Haram.
Possiamo tracciare, come lei fa puntualmente nel suo ultimo libro, una tendenza netta infra-europea al nazional-liberalismo (in Francia, Le Pen insiste sul nazionale e Macron sul liberale). Tuttativa, un quesito si pone nel momento in cui si cambia scala: la tendenza nazional-liberale della politica europea continentale è effettivamente vera? Come spiega il fatto che possa non esserlo?
Si, certo, visto che il nazional-liberalismo su scala nazionale è indissociabile dalla “governance” – preferirei dire governabilità in senso foucaultiano”- su scala europea. Tutte le politiche pubbliche degli Stati membri dell’Unione sono passate attraverso il suo setaccio, parametrate per il loro grado di adesione al neoliberalismo, ultima montatura del nazional-liberalismo.
L’inter-governalibilità paralizza l’insieme del continente nel neoliberalismo, permettendo di scaricare ogni responsabilità politica, ogni accountability, sulla cattiva Bruxelles.
Di fronte al neoliberalismo di Bruxelles, i popoli europei sono come i Curiazi: elettoralmente, si fanno ammazzare l’uno dopo l’altro. L’alternanza non sarà possibile fin quando non ci sarà un esercizio europeo di suffraggio universale; ed è esattamente questa la ragione per la quale i governi nazional-liberali non ne vogliono sentir parlare, attaccandosi ad un’Europa dell’inter-governabilità. Ed è questa a paralizzare l’insieme del continente nel neoliberalismo, permettendo di scaricare ogni responsabilità politica, ogni accountability, sulla cattiva Bruxelles.
Un interessante esperimento da laboratorio: come si riconfigurerà il nazional-liberalismo nel Regno Unito post Brexit? Di certo il “UK first” non rinuncerà alla globalizzazione liberale, come lo attesta la storia dell’imperialismo britannico, avendo sempre prediletto i suoi interessi finanziari a scapito di quelli industriali, commerciali e territoriali; così come l’hanno dimostrato Cain e Hopkins. Stesso grado di eloquenza per quanto riguarda il trumpismo: quest’ultimo infatti vuole richiamarsi al protezionismo commerciale e demografico, ma nomina al Tesoro un Goldman Sachs.
Nel suo ultimo libro, lei insiste a svariate riprese sugli errori di interpretazione che possono essere causati da una certa chiave di lettura, chiave che implica una sorta di schizofrenia dagli effetti disastrosi. Quali sono, a suo avviso, les discipline interne alle scienze sociali (od alle scuole ed instituzioni) che permettono di controbilanciare più facilmente questa schizofrenia?
Sicuramente l’economia, girando la schiena all’economia politica, e la scienza politica, sposando la normatività della “governance”, si dimenticano del potere –in effetti il concetto di governance è Foucault senza potere- trasformando i loro ricercatori ed insegnanti in “cani da guardia” del nazional-liberalismo. Di certo i miei colleghi non soffocano sotto il peso del loro senso critico – inteso in senso filosofico e non militante.
Il ricercatore deve praticare quel senso di straniamento tanto caro a Brecht, e da me definito cinismo euristico.
Vorrei semplicemente far presente che il ricercatore deve praticare quel senso di straniamento tanto caro a Brecht –Verffremdungseffkt, di solito mal tradotto come distanziamento, allorché Brecht si riferisce in modo esplicito al Distanzierung-, e da me definito cinismo euristico. In effetti un intellettuale organico dovrebbe mettersi nella posizione di impedire il pensiero circolare, non essere porta-parola del governare in modo circolare.
02
Pop Politics. La politica è spettacolo

Dove Michele Magno ci racconta che tutto il contemporaneo della Pop Politics partì con Ronald Reagan e proseguì nell'assoluzione e dissoluzione del partito politico, nell'ascesa di leadership individuali, nella discesa rumorosa delle forze anti- e affermazione del "peggiore" come classe dominante della soap opera della battaglia politica sintetizzata in tweet.
di Michele Magno
Nel 1966, due anni dopo il discorso citato qui l'altro ieri dal titolare di List, “A Time for Choosing”, in un’intervista al Los Angeles Times Ronald Reagan (allora candidato a governatore della California) al giornalista che gli chiedeva cosa fosse per lui la politica, rispose: “È solo un pezzo dell’industria dello spettacolo”. Il futuro presidente degli Stati Uniti, considerato già allora come un attore da strapazzo e un rozzo conservatore, l’aveva quindi capito ancor prima di un raffinato intellettuale marxista come Guy Debord (il cui saggio La società dello spettacolo venne pubblicato per la prima volta nel 1967).
In Italia, la spettacolarizzazione della politica ha subito una brusca accelerazione grazie alla discesa in campo di Silvio Berlusconi. Essa, nel bene e nel male, ha influenzato la politica nazionale fino ai nostri giorni, riproponendo prepotentemente il tema della leadership personale. Un genus che ha attecchito rapidamente sul fertile humus del Belpaese, con variazioni sullo stesso tema: il capo come origine e identità del partito politico, custode dell'ideologia (o del programma) e dominus delle istituzioni.
In Europa, solo dopo il secondo conflitto mondiale i settori più radicali del movimento operaio accettarono un'idea di democrazia vicina a quella elaborata da Joseph Schumpeter. Secondo il grande economista austriaco, il metodo democratico è
"lo strumento istituzionale per giungere a decisioni politiche, in base al quale singoli individui ottengono il potere di decidere attraverso una competizione che ha per oggetto il voto popolare" (Capitalismo, socialismo, democrazia, Etas, 2001).
Ora, perché nel passaggio di secolo, in forma prima silenziosa poi via via più rumorosa e eclatante, la sfiducia nei partiti, ovvero nei pressoché esclusivi interpreti di quel modello di democrazia, è esplosa così clamorosamente?
Da noi, la risposta che ha ricevuto più credito è anche la più semplice: la "casta" è diventata insopportabile perché i leader sono peggiorati. Come si suol dire, "non ci sono più i capi di una volta". Le élite non sono più, come scriveva Vilfredo Pareto, classi elette composte da coloro che eccellono nei vari campi, compreso quello dell'arte di governare. Nell'analisi di Roberto Michels era scontato che i capi fossero migliori della massa. Soprattutto "nei partiti del proletariato -scriveva nel 1911- in fatto di cultura, i duci sono di gran lunga superiori all'esercito". Come si legge nella Sociologia del partito politico (il Mulino, 1966),
"la gratitudine delle masse verso personalità che in nome loro parlano e scrivono, che si sono create la fama di difensori e consiglieri del popolo, [...] è naturale e spesso trascende in vera e propria tendenza delle masse alla venerazione dei capi".
Nulla di tutto ciò sembra oggi possibile, come ha osservato Marco Revelli in un aureo libretto (Finale di partito, Einaudi, 2013). Le leadership di partito attuali sono ampiamente screditate, tanto che l'unica rivendicazione unanime che si leva "dal basso" ogni qualvolta si parla di riforma elettorale, è quella di sottrarre alle segreterie il potere di decidere le candidature. La folla di funzionari e di quadri intermedi che occupa gli apparati, così come la moltitudine dei parlamentari, sono spesso bollate come esempio di impreparazione, di cattiva conoscenza dei problemi, di inefficienza e parassitismo. Sono inoltre bollate come venali e affaristiche, marcate dal vizio del privilegio e da uno spirito corporativo, oltre che da un diffuso servilismo.
È una spiegazione, questa, che però non spiega per quale motivo oggi i meccanismi della democrazia rappresentativa, anziché i migliori, selezionino i peggiori. Su questo nodo esiste una letteratura sterminata, che attribuisce alle trasformazioni di sistema -consumatesi nei decenni terminali del Novecento- le ragioni del degrado della rappresentanza politica nei regimi democratici. In un libro del 1974, Il declino dell'uomo pubblico (Bruno Mondadori, 2006), Richard Sennet poneva all'origine della progressiva erosione della vita pubblica una vera e propria apocalisse culturale, segnata dall'emergere di un Io ipertrofico e insieme vuoto, che tende a proiettare sullo spazio pubblico la propria soggettività narcisistica: sentimenti, emozioni, pulsioni, desideri di successo e di visibilità. Lo stesso spazio pubblico viene così invaso da linguaggi e stili narrativi di una soap opera, in un continuo, banale e seriale disvelamento di sé ormai scevro da ogni mistero o pudore. È quanto un altro acuto indagatore della “cultura del narcisismo”, Christopher Lasch, ha sintetizzato con l'espressione "ribellione delle élite", imputando alle minoranze dominanti gli stessi vizi e le stesse debolezze che nel 1930 un altro interprete della crisi della modernità, Ortega y Gasset, aveva attribuito a quelli che dovrebbero costituire i loro rappresentati.
In un quadro istituzionale tendenzialmente delegittimato, in cui si sgretolano le basi materiali della fiducia sociale, non sorprende quindi che nel nostro paese sia riemersa una "tentazione populista" anche nelle forme -fin qui del tutto inedite- della cosiddetta "democrazia digitale". Al di fuori delle retoriche pantecnologiche, è infatti evidente che le procedure della decisione telematica tendono a cancellare la fase necessariamente problematica e riflessiva della discussione e dell'analisi dei problemi, per promuovere invece i fattori emotivi, le sensazioni immediate, le pulsioni istintive. E anche questo è un paradosso del nostro tempo: che a una sicuramente più vasta acculturazione e conoscenza finisca per corrispondere una contestuale contrazione del momento dell'esame e della deliberazione argomentata, compresso fino alla dimensione puntiforme del fatidico clic. Tanto più benvenuta, pertanto, è nel panorama dell’informazione domestica una novità come quella costituita da List, le cui pagine “non si cliccano, ma si leggono”. È un’impresa che merita ogni fortuna.
03
Metropolis. Fuori la Democrazia, dentro la Città-Stato

Dove Lorenzo Castellani ci dice che Stato e democrazia sembrano in agonia, pezzi di una scacchiera che vengono via via sostituiti da elementi nuovi. Le pagine di un libro visionario confermato dal disordine ma pronto ad essere smentito dal ruggito della Storia. Il passaggio in una terra incognita, dove si scontrano i battaglioni dell'Antico e del Moderno, del remoto e del presente.
di Lorenzo Castellani
S’intitola “La rinascita delle città-Stato” (Fazi Editore, 2017) ed è il nuovo provocatorio pamphlet di Parag Khanna, saggista e advisor governativo di fama mondiale. Khanna è un pensatore sui generis e ha già abituato i suoi lettori a letture alternative della realtà: ne “L’età ibrida. Il potere della tecnologia nella competizione globale” (Codice, 2013) ha illustrato come l’integrazione tra pubblico e privato diventerà sempre più forte nei prossimi anni con attori privati, come i grandi player tecnologici, sempre più simili a poteri pubblici e capitali pubblici, come i fondi sovrani, capaci di muoversi attraverso società private e regole di mercato. In “Connectography” (Fazi Editore, 2016) ha raccontato la globalizzazione da un’angolazione diversa, non solo mercati integrati ma sgretolamento dei vecchi confini statuali riarticolati intorno a grandi metropoli ed infrastrutture. Per Khanna la globalizzazione non si articola in Stati e continenti ma in supply chains, grandi catene commerciali e reti tecnologiche in base alle quali si determina il livello di prosperità di un territorio. In questo breve pamphlet lo studioso americano distrugge uno dopo l’altro gli idoli democratici sorti alla fine del ventesimo secolo: la tecnocrazia deve contare almeno quanto la politica, la partecipazione è il futuro rispetto al consenso, la buona governance è più importante della democrazia e, da ultimo, la città metropolitana disgregherà la consunta carcassa dello Stato moderno. Il ventunesimo secolo? Fuori Stato centrale, consenso popolare e democrazia, dentro città autonome, competenza e tecnocrazia partecipata. Una versione eretica, quella dell’autore, sia rispetto alle posizioni moderate liberal-democratiche che rispetto a quella dei nuovi movimenti populisti e nazionalisti.
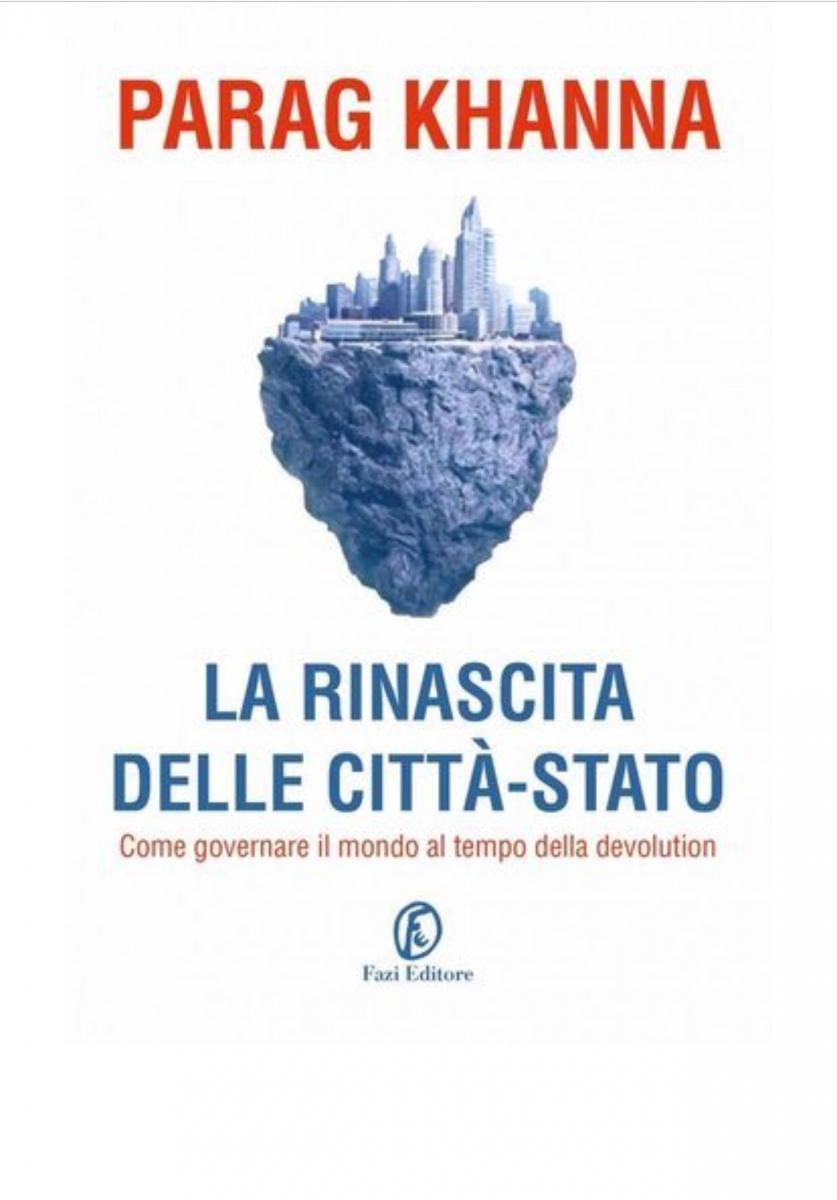
Khanna sostiene che la cura per la crisi di performance delle democrazie liberali non sia tanto nel concentrarsi sulle nuove forme della politica quanto sulla costruzione di una tecnocrazia partecipata. Ciò non significa istituire governi non elettivi, ma semplicemente rafforzare con le competenze la logica democratica, migliorando le performance dei servizi pubblici senza appesantire le casse dell’erario pubblico e, quindi, la fiscalità a carico dei cittadini. Un passaggio fondamentale per aumentare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e rafforzare le realizzazione delle promesse politiche da parte di chi è chiamato a guidare una nazione. Infatti, il principale problema delle democrazie odierne risiede nel gap incolmabile tra aspettative dei cittadini e capacità dei governi nel soddisfarle. Secondo un sondaggio del World Values Survey (2016) in Europa e negli Stati Uniti dal 1946 a oggi la fiducia nella democrazia come forma di governo è passata da due terzi a un terzo, mentre la fiducia negli esperti è aumentata dal 32 al 49%.
Khanna non si fa portatore di alcun credo anti-democratico ma guarda ad esempi virtuosi del mondo globale: la tecnocrazia competente e creativa di Singapore da un lato e la prospera democrazia Svizzera dall'altro. La selezione meritocratica della burocrazia effettuata dalla città-Stato asiatica, senza ricorrere a partigianerie politiche ma attraverso logiche simili a quelle del libero mercato, è la via per far funzionare meglio la democrazia, renderla operativa e pragmatica rispetto alle promesse delle campagne elettorali. Il sistema amministrativo di Singapore, al contrario di quanto si possa pensare, non vive isolato dal proprio popolo ma applica probabilmente la più avanzata forma di democrazia deliberativa al mondo. I burocrati-manager svolgono, infatti, vere e proprie ricerche di mercato sulle esigenze dei cittadini attraverso sondaggi d'opinione, dibattiti pubblici, valutazione dei servizi pubblici da parte degli utenti. Queste operazioni permettono agli amministratori di Singapore di accumulare dati e conoscenze sull'efficacia delle politiche decise dall'esecutivo e di correggere la rotta nel corso del tempo migliorando l'erogazione dei servizi senza gravare sulle tasche dei contribuenti. È stato costruito un sistema di tecnocrazia consultiva capace di integrare partecipazione del popolo ed efficacia amministrativa che si è sviluppato negli ultimi dieci anni, grazie anche all'aiuto delle nuove tecnologie, migliorando significativamente le performance dei servizi offerti. Le virtù della democrazia elvetica, invece, sono ben più note a noi italiani: competizione federale, referendum locali, direttorio per le decisioni collegiali di maggior peso per la Confederazione, capacità della pubblica amministrazione di essere lo snodo tra i desideri elettorali e la pragmatica realizzazione delle politiche. Tutto con una politica economica ordinata, controllo della spesa pubblica e pressione fiscale ridotta.
Richiamando questi due esempi Khanna sostiene una tesi limpida: non si può rinunciare alla democrazia liberale, ma bisogna riparare il modello che abbiamo oggi con iniezioni di competenze e capacità di elaborare scenari, strategie e valutazioni delle politiche pubbliche. Oltre ad ottenere un maggiore e migliore controllo sui governanti da parte dei cittadini attraverso forme di devolution verso le città sempre più rafforzate. Il suffragio universale, e i politici eletti, non bastano più nell'era dell'Info-State, lo Stato postmoderno pervaso dall'informazione di massa e da una enorme quantità di dati. Il Leviatano 3.0, e i suoi vertici, dovranno decidere in breve se canalizzare il grande capitale dell'informazione per migliorare l'efficienza amministrativa e i risultati delle politiche o se annegare lasciando ai partiti, alla democrazia diretta e ai movimenti di protesta questo cumulo di dati, risorse e preferenze espresse dai cittadini. Se si vuole scegliere la prima strada, scrive Khanna, la democrazia dovrà essere temperata con la nuova tecnocrazia capace di controllare le implicazioni di lungo periodo delle decisioni politiche e offrire strumenti correttivi. Ciò significa che per i sistemi politici del futuro servirà molto di più l'edificazione di una buona governance, che si alimenta di competenze e nuove ripartizioni territoriali del potere, rispetto ad una perenne campagna elettorale da parte dei leader politici.
04
Contrasti. Un liberale smarrito a Barcellona

Dove un liberale (ir)risolto scopre il dissidio interiore, l'imperfezione dell'idea, la forse inconciliabile relazione tra l'ideale e il reale, l'aspirazione e l'azione, lo stato di Calexit di Massimiliano Trovato di fronte alla libertà della e dalla secessione. Passeggiare a Barcellona e ritrovarsi né secessionista né unionista né terzista.
di Massimiliano Trovato
In questi giorni ispidi, i liberali risolti planano su Barcellona con i trolley pieni di certezze: i più moderati, con spirito ottocentesco, per difendere l’estado de derecho; i più audaci, con furore futurista, per testimoniare l’atteso declino dello stato nazionale. Poi c’è il liberale problematico, paralizzato sulle ramblas con la cartina in mano, incapace di battezzare una direzione. Quando ha visto due milioni di catalani farsi strada tra i manganelli di Madrid per dire sì all’autonomia, il liberale problematico – o almeno questo liberale problematico – ha tentato, con una certa pervicacia, di appassionarsi alla causa; ma quando lo stesso liberale problematico ha visto un altro milione di catalani – 350 mila según la policía; anzi: segons la policia – scendere in piazza per l’unità nazionale, gli si sono incrociate le pupille. È riaffiorata, nel liberale problematico, la familiare sensazione che la seggiola della realpolitik fosse eccessivamente angusta per il suo pensoso deretano e che, nel derby ideologico tra il governo e la Generalitat, l’opzione più ragionevole fosse quella terzista: né con Rajoy, né con Puigdemont.
Eppure il liberale problematico è perfettamente a proprio agio con la teoria delle piccole patrie: unità politiche di dimensioni più contenute riducono la distanza tra governanti e governati, rendendo più efficace il controllo di questi ultimi sull’operato dei primi; favoriscono il voto coi piedi, cioè la defezione (difficile smentire che migrare da Barcellona a Valencia sia, tutto sommato, meno oneroso che abbandonare Mosca per Vienna); circoscrivono i costi dell’azione collettiva senza pagare dazio – pun intended – in termini di accesso ai mercati globali; favoriscono la sperimentazione istituzionale e, dunque, l’evoluzione di meccanismi sociali più funzionali e robusti; e chissà mai che, di secessione in secessione, non riescano pure a precipitare l’indipendenza dell’unica minoranza che il liberale problematico abbia veramente a cuore: l’individuo.
Se, poi, l’effetto sistemico di una simile ondata particolaristica fosse quello di disgregare l’idea di sovranità nazionale, a dolersene non sarebbe certo il liberale problematico – che, quando non vuole eliminare lo stato, vuole almeno rimpicciolirlo abbastanza da poterlo affogare in una vasca da bagno, per prendere a prestito l’arrapante allegoria di Grover Norquist. L’equivoco, però, risiede esattamente in questo, nell’equazione tra stato minimo e stato minuscolo: il liberale problematico non mira a fare a fette il potere, bensì a polverizzarlo. E proprio il caso di Barcellona solleva perplessità tutt’altro che banali da questo punto di vista: una Catalogna autonoma sarebbe giocoforza una Catalogna più libera? E, soprattutto, lo sarebbe tanto per i catalani indipendentisti quanto per quelli unionisti? Alcuni indici fanno temere il contrario.
In primo luogo, la campagna per la secessione della Generalitat è colorata da una marcata componente identitaria, sicché, più che al tentativo di scardinare l’identità spagnola, assistiamo alla sfida tra due opposti nazionalismi. Del resto, uno straordinario indagatore del pluralismo istituzionale come Gianfranco Miglio insegnava, trent’anni fa, che «le grandi Nazioni non esistono» e che il vero nazionalismo è il «micro-nazionalismo», cioè quello di «aggregati tenuti insieme non da grandi principî, da grandi ideali, ma da un minuto reticolo di molteplici affinità, da radicate abitudini quotidiane»; il che, beninteso, non era una controindicazione agli occhi dello studioso comasco, che anzi se ne serviva per smascherare la natura mimetica del «macro-nazionalismo»; e, tuttavia, questa pretesa d’omogeneità etnica e culturale dovrebbe preoccupare il liberale problematico, che è necessariamente cosmopolita.
Quest’elemento, per inciso, distingue la vicenda catalana da quella – ad essa impropriamente accostata – delle regioni italiane del Nord, il cui anelito di autonomia (peraltro assai più blando) ha un contenuto essenzialmente utilitaristico, come confermano indirettamente i numeri: il residuo fiscale della Catalogna è di meno di 10 miliardi di euro l’anno: circa la metà di quello veneto e un quinto di quello lombardo. Questa constatazione allude a un secondo motivo di scetticismo: indipendenza sì, ma per farci cosa? La maggioranza autonomista di Barcellona è un’accozzaglia che tiene insieme democristiani paludati e comunisti da operetta: una volta risolto l’annoso problema dell’insegnamento del catalano nelle scuole, quali prospettive per il futuro della regione potranno unire questi improbabili alleati? Una Catalogna indipendente diventerebbe la Hong Kong d’Europa o un angolo di Bolivia affacciato sul Mediterraneo?
Terzo profilo critico: siamo proprio sicuri che la causa della secessione sia plebiscitaria nella società catalana? Al referendum del primo ottobre ha partecipato poco più del 40 per cento degli aventi diritto: certo, i custodi della democrazia in assetto da sommossa all’ingresso dei seggi non sono un grosso incentivo alla partecipazione, ma gli sviluppi delle ultime due settimane hanno evidenziato la presenza – e la consistenza relativa – d’istanze contrarie. Come conciliare l’esistenza di queste due anime attraverso un processo maggioritario che necessariamente esclude ogni possibilità di contemperamento? Si fa presto a parlare di autodeterminazione dei popoli, ma occorre una certa dose di sospensione dell’incredulità.
Anticipo le obiezioni dei liberali risolti: il liberalismo è una dottrina di principî (“il rispetto della legalità!”, sbraitano gli ottocenteschi; “la libertà di scelta!”, ribattono i futuristi) e io mi sto trastullando con le loro conseguenze concrete. Piano: la legalità non può essere la camicia di forza del cambiamento; e la libertà di scelta compete alle persone, non ai popoli – qualunque cosa siano. Per parte mia, credo – con i futuristi – che un liberalismo coerente non possa prescindere dal diritto di secessione: ma anche che questo diritto vada esercitato con la massima accortezza a tutela degli individui: perché è vero che, da gabbie più piccole, può essere più agevole scappare, ma – in attesa della fuga – la permanenza rischia di essere ben più dolorosa.
05
Governare. E non sapere cosa accadrà
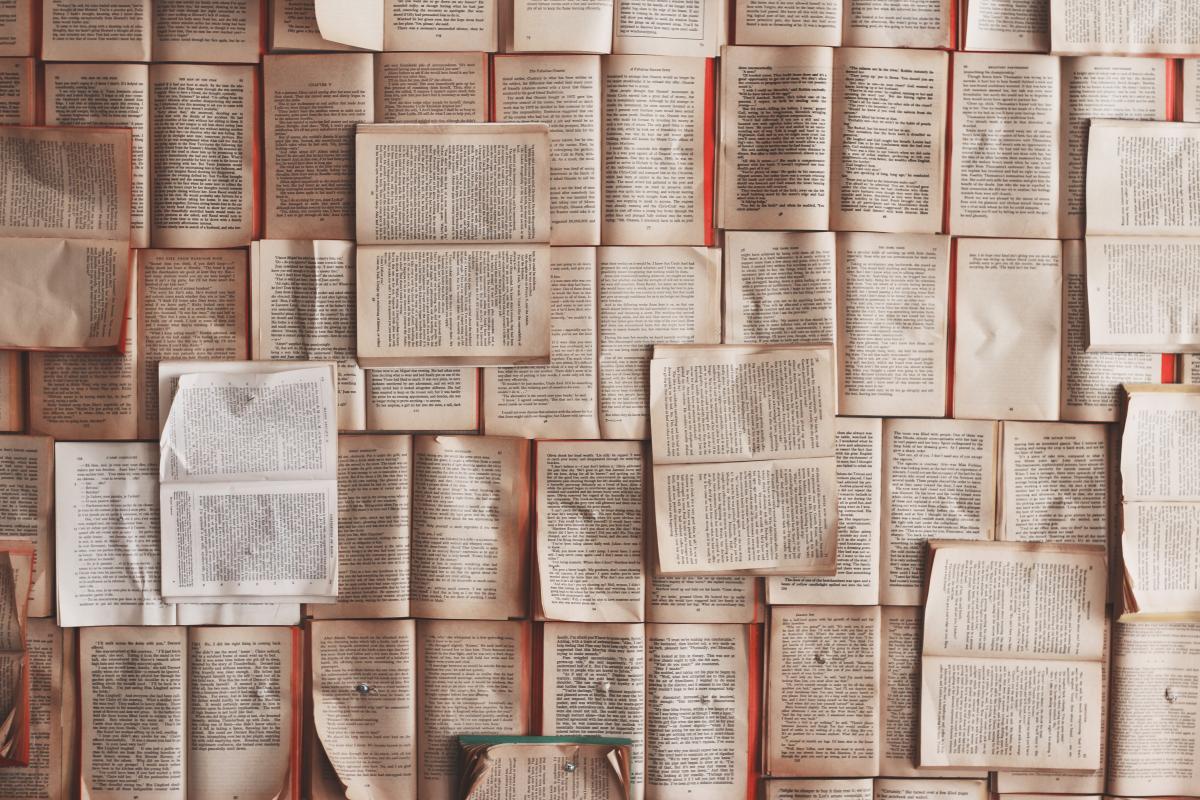
Dove la tecnica e la politica non si incrociano e la misurazione è un'opinione. Vitalba Azzollini nel mare dei codici, delle parole, delle azioni e reazioni, delle conseguenze inattese e regole disattese. Fare, non fare, disfare la legge. Promettere senza mantenere. Un ritratto dell'amministrazione che non si ricorda mai del mercato e dei suoi protagonisti. Alla fine, tutto conduce alla creazione all'italiana del suddito inconsapevole.
di Vitalba Azzollini
In una “puntata” precedente qui su List ho provato a spiegare la “cultura” degli impatti: vale a dire quel metodo di regolamentazione che impone al governo e ad altre autorità di definire con trasparenza gli obiettivi perseguiti, di valutare ex ante comparativamente gli effetti di diverse opzioni normative (inclusa quella di non intervento), di fissare indicatori di risultato per vagliare ex post se quella prescelta è stata efficace, nonché di redigere un’apposita relazione con tali contenuti. Non è solo un metodo di better regulation, ma anche il modo per inchiodare i governanti alle responsabilità conseguenti ai propri annunci, vincolandoli a rendicontarne i risultati. Sarà per questo che AIR e VIR (analisi e verifica di impatto della regolamentazione) piacciono poco a politici e supporter, nonostante siano obbligatorie ex lege da anni. Detto ciò, può essere utile esporre i settori in cui l’analisi va fatta, verificando se e come “funzioni”: insomma, una verifica di impatto sull’analisi di impatto, e non è un gioco di parole.
Ai sensi di legge, la valutazione ex ante degli impatti va svolta secondo direttrici ben precise: se la futura normativa ha fra i suoi destinatari piccole e medie imprese, ne vanno analizzati gli eventuali effetti distorsivi o sproporzionati rispetto alle imprese di più grandi dimensioni; inoltre, devono essere misurati eventuali nuovi adempimenti a carico di cittadini e imprese; serve altresì stimare l’incidenza delle diverse opzioni di regolazione sulle dinamiche concorrenziali del mercato, scegliendo quella che le sacrifica meno; in caso di recepimento di normative comunitarie, occorre verificare che non siano introdotti obblighi superiori a quelli richiesti da tali normative (c.d. gold-plating). E’ importante poi valutare preventivamente anche le modalità attuative - strumenti, risorse e mezzi - dell’intervento di regolamentazione. Questo è quanto espressamente (e teoricamente) prescritto. Ma i legislatori ne tengono realmente conto?
Partiamo dal primo punto. È’ necessario esaminare che nuove disposizioni non impongano pesi burocratici gravanti in misura maggiore sulle piccole e medie imprese, poiché “l’evidenza empirica mostra in modo inequivocabile come gli oneri (…) legati all’adempimento di una norma siano, in proporzione, molto più elevati per le PMI rispetto alle imprese di taglia media e grande” (Formez PA). Al riguardo, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato osserva che “il cammino intrapreso verso l’adozione di regolazioni che ‘pensano in piccolo’ potrà produrre risultati positivi per (…) le piccole e medie imprese, a condizione che i modelli di analisi d’impatto vengano attuati in modo concreto e sostanziale”. E, infatti, l’UE ha predisposto da tempo un test (c.d. test PMI) utile a stimare gli impatti – appunto - degli adempimenti amministrativi sulle imprese di dimensioni minori. Ma di questo test non sembra esservi traccia nelle relazioni AIR nazionali. Le conseguenze sono palesi: un recente studio di Assolombarda in tema di oneri amministrativi nei settori ambiente, edilizia, fisco ecc. dimostra che i costi delle relative procedure (in termini di percentuale sul fatturato e di ore per addetto) continuano a incidere più sulle PMI che sulle grandi imprese. E di studi che attestano queste evidenze ve ne sono comunque molti altri.
Circa il secondo punto, cioè la stima - in sede di elaborazione di nuove normative - degli oneri burocratici gravanti su cittadini e imprese (con quantificazione dei relativi costi), essa è funzionale al c.d. budget regolatorio, previsto ex lege dal 2012. Si tratta di un meccanismo di compensazione c.d. one-in-one-out, per cui non possono essere introdotti nuovi oneri amministrativi senza contestualmente ridurne o eliminarne altri. Questo principio viene osservato? La risposta la fornisce il Consiglio di Stato, il quale pochi mesi fa ha rilevato che, mentre in altri Paesi si stanno sfoltendo molti pesi, elaborando sistemi one-in-two-out o addirittura one-in-three-out, la regola in Italia è pressoché ignorata. Rimando a quanto ho scritto altrove, aggiungendo che, nonostante recenti misure tese a semplificazioni varie, permane “una grave incertezza sul regime amministrativo delle singole attività, sulla stabilità dei titoli abilitativi (impliciti o presunti), sui tempi di definizione delle procedure” (C. Deodato), nonché su molto altro.
Il terzo punto è il full competition assessment, cioè la quantificazione degli impatti concorrenziali, utile a evitare ostacoli ingiustificati all’esercizio delle attività economiche: ma chi l’ha visto? E’ lo stesso Nucleo AIR presso la presidenza del Consiglio ad attestarlo: in sede di elaborazione di nuove regolamentazioni, ci si limita a svolgere “considerazioni apodittiche sull’intervento come ausilio alla competitività e nessuna considerazione specifica laddove l’intervento limiti o distorca il mercato”. Serve altro per dimostrare il senso (mancante) dei regolatori nazionali per la competizione fra privati? Forse sì: ad esempio, ricordare il non lusinghiero 54° posto che l’Italia occupa attualmente nell'Indice Libertà Economiche elaborato dal Fraser Institute (era al 24° posto nel 2000); o la circostanza che per partorire la prima (rachitica) normativa sulla concorrenza sono serviti 8 anni dalla legge istitutiva e circa 900 giorni di discussione.
Per quanto poi attiene al divieto di gold-plating, nelle relazioni AIR i regolatori dovrebbero dare conto del fatto che, nella trasposizione di discipline comunitarie nell’ordinamento interno, non hanno immotivatamente previsto oneri, requisiti, procedure ecc. più gravosi di quelli contenuti nelle discipline medesime. Questo limite viene rispettato? I dati empirici sono chiari: “il 32% (o 3,5% del PIL) dei costi amministrativi di provenienza europea a carico di un’impresa sono da ascriversi, per la stessa Commissione, all’inefficace recepimento del diritto europeo negli Stati membri, e il 4% di essi al solo gold-plating” (E. Ojetti). Inoltre, basta leggere qualche relazione di analisi di impatto nazionale per accertare che non viene fatto un esame attento e puntuale sul gold-plating e che, pertanto, il rischio di violazione è molto alto.
Infine, non mi dilungherò sulla valutazione di strumenti e modalità di implementazione di nuove discipline, rimandando a quanto scritto altrove: in sintesi, come può pensarsi che qualcuno la svolga ex ante, se in Italia non esiste un’autorità preposta a verificare ex post l’effettiva attuazione di “politiche” e relative normative? Né mi dilungherò su analisi di impatto riguardanti profili quali il genere, la salute ecc., svolte in altri Paesi: a cosa servirebbe, se nel nostro le AIR non affrontano neanche quei pochi profili già previsti? A questo punto concludo. Le domande retoriche stanno diventando un po’ troppe.
Iscriviti per leggere l'articolo completo.
30 giorni gratis per te
Ti manca poco per entrare nel Club. Completa la registrazione
Ti abbiamo mandato una mail su . Per completare la registrazione, apri la mail che ti abbiamo mandato e fai clic sul link di conferma. Grazie!
INFORMATIVA PRIVACY RELATIVA AL SERVIZIO NEWSLIST
Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice privacy”), dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679 del 2016 (il “Regolamento privacy”), del Provvedimento n. 229 del 2014 del Garante della Protezione dei Dati Personali (rubricato “Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l'uso dei cookie”), nonché della Raccomandazione n. 2 del 2001 adottata ai sensi dell’art. 29 della Direttiva n. 95/46/CE, List S.r.l. intende informare gli Utenti in merito all’utilizzo dei loro dati personali, dei log files e dei cookie raccolti tramite la navigazione nel Sito www.newslist.it (di seguito, il “Sito”).
- Titolare, Responsabili del trattamento dei dati e Responsabile della Protezione dei Dati
Il titolare del trattamento dei dati personali è List S.r.l. (di seguito, il “Titolare” o “List”), con sede legale Roma (00196), Via Ferdinando di Savoia n. 3, partita IVA 14403801005, email help@newslist.it.
L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento, ove designati, può essere fornito su richiesta da parte degli Utenti.
Nel caso in cui venga nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (ai sensi dell’art. 37 del Regolamento privacy), i dati identificativi dello stesso saranno resi noti mediante pubblicazione dei medesimi, integrando la presente informativa.
Il titolare del trattamento dei dati personali relativi al Sito è Legalitax Studio Legale e Tributario, con sede in Roma (00196), Via Flaminia n. 135.
- Categorie, natura e finalità dei dati trattati
List tratterà alcuni dati personali degli Utenti che navigano e interagiscono con i servizi web del Sito.
- Dati di navigazione
Si tratta di dati di navigazione che i sistemi informatici acquisiscono automaticamente durante l’utilizzo del Sito, quale l’indirizzo IP, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier), nonché i dettagli delle richieste inviate al server del Sito, e che ne rendono possibile la navigazione. I dati di navigazione potranno altresì essere utilizzati per compilare statistiche anonime che permettono di comprendere l’utilizzo del Sito e di migliorare la struttura dello stesso.
Infine, i dati di navigazione potranno eventualmente essere utilizzati per l’accertamento di attività illecite, come in casi di reati informatici, a danno del Sito.
- Dati forniti dall’Utente
L’eventuale invio di comunicazioni ai contatti indicati sul Sito comporta l’acquisizione dell’indirizzo e-mail e degli ulteriori dati personali contenuti nella comunicazione, previo rilasci di idonea informativa.
- Cookie
- Siti web di terze parti
I siti di terze parti a cui è possibile accedere tramite questo Sito non sono coperti dalla presente Privacy policy. Gli stessi potrebbero utilizzare cookie differenti e/o adottare una propria Privacy policy diversa da quella di questo Sito, relativamente ai quali quest’ultimo non risponde. Consigliamo pertanto di consultare di volta in volta la relativa informativa sull’utilizzo dei cookie e seguire le istruzioni per la disabilitazione degli stessi, qualora lo si desiderasse.
- Natura del conferimento dei dati
Fermo restando quanto indicato in relazione ai dati di navigazione e ai cookie, gli Utenti sono liberi di fornire i propri dati personali, ove richiesti nelle apposite sezioni del Sito; il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ricevere la fornitura dei servizi da loro richiesti.
- Modalità del trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, e per il periodo di tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Le informazioni raccolte sono registrate in un ambiente sicuro.
- Ambito di comunicazione dei dati
I dati personali degli Utenti saranno trattati dal personale incaricato di List. Inoltre, i loro dati personali potranno essere trattati da terzi, fornitori di servizi esterni, che agiscano per conto o a nome di List, debitamente nominati quali Responsabili del trattamento, e che tratteranno i dati in conformità allo scopo per cui i dati sono stati in origine raccolti.
- Diffusione dei dati
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
- Diritti dell’interessato
Il Codice privacy e il Regolamento privacy conferiscono agli Utenti l’esercizio di specifici diritti.
Gli Utenti in qualsiasi momento potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice privacy e s.m.i. e di cui agli art. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento privacy, inviando una comunicazione scritta ai recapiti del Titolare di cui al precedente paragrafo 1 e, per l’effetto, ottenere:
- la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali degli Utenti con indicazione della relativa origine, verificarne l’esattezza o richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione;
- l’accesso, la rettifica, la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento;
- la cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali trattati in violazione di legge.
Gli Utenti, inoltre, potranno opporsi al trattamento dei dati personali che li riguardano.
- Aggiornamenti
La Privacy policy del Sito potrà essere soggetta a periodici aggiornamenti.
Termini e condizioni di vendita dei servizi di abbonamento
I presenti termini d'uso disciplinano la fornitura digitale del servizio in abbonamento (di seguito,
il"Servizio" o
l'"Abbonamento") a List nelle diverse formule di volta in volta disponibili. Il Servizio è fornito da List
S.r.l., con
sede in Via Ferdinando di Savoia, 3 - 00196 Roma P. IVA 14403801005, iscritta al registro delle imprese di
Roma, numero
di iscrizione RM/1518421 (di seguito, il "Fornitore").
Il Servizio è rivolto esclusivamente a utenti maggiorenni. (di seguito, l'"Utente" o gli "Utenti").
List è il servizio digitale che fornisce agli Utenti contenuti editoriali, giornalistici e informativi di
qualità;
maggiori informazioni su List sono disponibili navigando sul sito internet https://newslist.it/ (di seguito,
il "Sito").
Il Servizio è disponibile in abbonamento via web a partire dal Sito, nonché attraverso l'applicazione List
(di seguito,
l'"Applicazione") per dispositivi mobili con sistema operativo IOS 11.0 o successivi e Android 6.0 o
successivi.
Il costo dei dispositivi, delle apparecchiature e della connessione internet necessari per la fruizione del
Servizio non
è ricompreso nel Servizio e si intende a carico dell'Utente.
1. Caratteristiche del Servizio
1.1 Il Servizio ha ad oggetto la fruizione in abbonamento dei contenuti editoriali della testata List.
L'Abbonamento è
disponibile esclusivamente in formato digitale; resta quindi espressamente esclusa dal Servizio la fornitura
dei
contenuti in formato cartaceo.
1.2 Il Servizio è a pagamento e comporta il pagamento di un corrispettivo a carico dell'Utente (con le
modalità previste
nel successivo articolo 5).
1.3 L'Utente può scegliere tra diverse formule a pagamento per la fruizione del Servizio; il costo, la
durata, le
modalità di erogazione e gli specifici contenuti di ciascun pacchetto sono specificati nella pagina di
offerta
pubblicata su https://newslist.it/fe/#!/register ovvero all'interno dell'Applicazione. Il contenuto
dell'offerta deve
intendersi parte integrante dei presenti termini d'uso e del connesso contratto tra il Fornitore e l'Utente.
2. Acquisto dell'abbonamento
2.1 Ai fini dell'acquisto di un Abbonamento è necessario (i) aprire un account List; (ii) selezionare un
pacchetto tra
quelli disponibili; (iii) seguire la procedura di acquisto all'interno del Sito o dell'Applicazione,
confermando la
volontà di acquistare l'Abbonamento mediante l'apposito tasto virtuale. L'Abbonamento si intende acquistato
al momento
della conferma della volontà di acquisto da parte dell'Utente; a tal fine, l'Utente accetta che faranno fede
le
risultanze dei sistemi informatici del Fornitore. La conferma vale come espressa accettazione dei presenti
termini
d'uso.
2.2 L'Utente riceverà per email la conferma dell'attivazione del Servizio, con il riepilogo delle condizioni
essenziali
applicabili e il link ai termini d'uso e alla privacy policy del Fornitore; è onere dell'Utente scaricare e
conservare
su supporto durevole il testo dei termini d'uso e della privacy policy.
2.3 Una volta confermato l'acquisto, l'intero costo dell'Abbonamento, così come specificato nel pacchetto
acquistato,
sarà addebitato anticipatamente sullo strumento di pagamento indicato dall'Utente.
2.4 Effettuando la richiesta di acquisto dell'Abbonamento, l'Utente acconsente a che quest'ultimo venga
attivato
immediatamente senza aspettare il decorso del periodo di recesso previsto al successivo articolo 4.
2.5 Per effetto dell'acquisto, l'Utente avrà diritto a fruire del Servizio per l'intera durata
dell'abbonamento;
l'Utente, tuttavia, non può sospendere per alcun motivo la fruizione del Servizio durante il periodo di
validità
dell'Abbonamento.
3. DURATA, DISDETTA E RINNOVO DELL'ABBONAMENTO
3.1 L'Abbonamento avrà la durata di volta in volta indicata nel pacchetto scelto dall'Utente (per esempio,
mensile o
annuale).
3.2 L'Abbonamento si rinnoverà ciclicamente e in modo automatico per una durata eguale a quella
originariamente scelta
dall'Utente, sino a quando una delle Parti non comunichi all'altra la disdetta dell'Abbonamento almeno 24
ore prima del
momento della scadenza. In mancanza di disdetta nel termine indicato, l'Abbonamento è automaticamente
rinnovato.
3.3 L'Utente potrà esercitare la disdetta in ogni momento e senza costi attraverso una delle seguenti
modalità:
seguendo la procedura per la gestione dell'Abbonamento all'interno del proprio profilo utente sia sul Sito
che
nell'Applicazione;
inviando una mail al seguente indirizzo: help@newslist.it.
3.4 Gli effetti della disdetta si verificano automaticamente alla scadenza del periodo di abbonamento in
corso; fino a
quel momento, l'Utente ha diritto a continuare a fruire del proprio Abbonamento. La disdetta non dà invece
diritto ad
alcun rimborso per eventuali periodi non goduti per scelta dell'Utente.
3.5 In caso di mancato esercizio della disdetta, il rinnovo avverrà al medesimo costo della transazione
iniziale, salvo
che il Fornitore non comunichi all'Utente la variazione del prezzo dell'Abbonamento con un preavviso di
almeno 30 giorni
rispetto alla data di scadenza. Se, dopo aver ricevuto la comunicazione della variazione del prezzo,
l'Utente non
esercita la disdetta entro 24 ore dalla scadenza, l'Abbonamento si rinnova al nuovo prezzo comunicato dal
Fornitore.
3.6 Il Fornitore addebiterà anticipatamente l'intero prezzo dell'Abbonamento subito dopo ogni rinnovo sullo
stesso
strumento di pagamento in precedenza utilizzato dall'Utente ovvero sul diverso strumento indicato
dall'Utente attraverso
l'area riservata del proprio account personale.
4. Recesso DEL CONSUMATORE
4.1 L'Utente, ove qualificabile come consumatore – per consumatore si intende una persona fisica che agisce
per scopi
estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, ha
diritto di
recedere dal contratto, senza costi e senza l'onere di indicarne i motivi, entro 14 giorni dalla data di
attivazione
dell'Abbonamento acquistato.
4.2 L'Utente può comunicare la propria volontà di recedere, inviando al Fornitore una comunicazione
esplicita in questo
senso mediante una delle seguenti modalità:
mediante raccomandata a.r. indirizzata alla sede del Fornitore;
per email al seguente indirizzo help@newslist.it;
4.3 Ai fini dell'esercizio del recesso l'Utente può, a sua scelta, utilizzare questo modulo
4.4 Il termine per l'esercizio del recesso si intende rispettato se la comunicazione relativa all'esercizio
del diritto
di recesso è inviata dall'Utente prima della scadenza del periodo di recesso.
4.5 In caso di valido esercizio del recesso, il Fornitore rimborserà all'Utente il pagamento ricevuto in
relazione
all'Abbonamento cui il recesso si riferisce, al netto di un importo proporzionale a quanto è stato fornito
dal Fornitore
fino al momento in cui il consumatore lo ha informato dell'esercizio del diritto di recesso; per il calcolo
di tale
importo, si terrà conto dei numeri o comunque dei contenuti fruiti e/o fruibili dal consumatore fino
all'esercizio del
diritto di recesso. Il rimborso avverrà entro 14 giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso sullo
stesso
mezzo di pagamento utilizzato per la transazione iniziale.
4.6 Eventuali eccezioni al diritto di recesso, ove previste da Codice del consumo – decreto legislativo 6
settembre
2005, n. 206, saranno comunicate al consumatore in sede di offerta prima dell'acquisto.
5. Modalità di pagamento
5.1 L'Abbonamento comporta l'obbligo per l'Utente di corrispondere al Fornitore il corrispettivo nella
misura
specificata nell'offerta in relazione al pacchetto scelto dall'Utente.
5.2 Tutti i prezzi indicati nell'offerta si intendono comprensivi di IVA.
5.3 Il pagamento dei corrispettivi può essere effettuato mediante carte di credito o debito abilitate ad
effettuare gli
acquisti online. Le carte accettate sono le seguenti: Visa, Mastercard, American Express.
5.4 L'Utente autorizza il Fornitore ad effettuare l'addebito dei corrispettivi dovuti al momento
dell'acquisto
dell'Abbonamento e dei successivi rinnovi sulla carta di pagamento indicata dallo stesso Utente.
5.5 Il Fornitore non entra in possesso dei dati della carta di pagamento utilizzata dall'Utente. Tali dati
sono
conservati in modo sicuro dal provider dei servizi di pagamento utilizzato dal Fornitore (Stripe o il
diverso provider
che in futuro potrà essere indicato all'Utente). Inoltre, a garanzia dell'Utente, tutte le informazioni
sensibili della
transazione vengono criptate mediante la tecnologia SSL – Secure Sockets Layer.
5.6 È onere dell'Utente: (i) inserire tutti i dati necessari per il corretto funzionamento dello strumento
di pagamento
prescelto; (ii) mantenere aggiornate le informazioni di pagamento in vista dei successivi rinnovi (per
esempio,
aggiornando i dati della propria carta di pagamento scaduta in vista del pagamento dei successivi rinnovi
contrattuali).
Qualora per qualsiasi motivo il pagamento non andasse a buon fine, il Fornitore si riserva di sospendere
immediatamente
l'Abbonamento fino al buon fine dell'operazione di pagamento; trascorsi inutilmente 3 giorni senza che il
pagamento
abbia avuto esito positivo, è facoltà del Fornitore recedere dal contratto con effetti immediati.
Pagamenti all'interno dell'applicazione IOS
5.7 In caso di acquisto dell'Abbonamento mediante l'Applicazione per dispositivi IOS, il pagamento è gestito
interamente
attraverso la piattaforma App Store fornita dal gruppo Apple. Il pagamento del corrispettivo è
automaticamente
addebitato sull'Apple ID account dell'Utente al momento della conferma dell'acquisto. Gli abbonamenti
proposti sono
soggetti al rinnovo automatico e all'addebito periodico del corrispettivo. L'Utente può disattivare
l'abbonamento fino a
24h prima della scadenza del periodo di abbonamento in corso. In caso di mancata disattivazione,
l'abbonamento si
rinnova per un eguale periodo e all'Utente viene addebitato lo stesso importo sul suo account Apple.
L'Utente può
gestire e disattivare il proprio abbonamento direttamente dal proprio profilo su App Store. Per maggiori
informazioni al
riguardo: https://www.apple.com/it/legal/terms/site.html. Il Fornitore non è responsabile per eventuali
disservizi della
piattaforma App Store.
6. Promozioni
6.1 Il Fornitore può a sua discrezione offrire agli Utenti delle promozioni sotto forma di sconti o periodi
gratuiti di
fruizione del Servizio.
6.2 Salvo che non sia diversamente specificato nella pagina di offerta della promozione, l'adesione a una
promozione
comporta, alla sua scadenza, l'attivazione automatica del Servizio a pagamento con addebito periodico del
corrispettivo
in base al contenuto del pacchetto di volta in volta selezionato dall'Utente.
6.3 L'Utente ha la facoltà di disattivare il Servizio in qualunque momento prima della scadenza del periodo
di prova
attraverso una delle modalità indicate nel precedente articolo 3).
7. Obblighi e garanzie dell'Utente
7.1 L'Utente dichiara e garantisce:
- di essere maggiorenne;
- di sottoscrivere l'Abbonamento per scopi estranei ad attività professionali, imprenditoriali, artigianali
o commerciali
eventualmente svolte;
- che tutti i dati forniti per l'attivazione dell'Abbonamento sono corretti e veritieri;
- che i dati forniti saranno mantenuti aggiornati per l'intera durata dell'Abbonamento.
7.2 L'Utente si impegna al pagamento del corrispettivo in favore del Fornitore nella misura e con le
modalità definite
nei precedenti articoli.
7.3 L'Utente si impegna ad utilizzare l'Abbonamento e i suoi contenuti a titolo esclusivamente personale, in
forma non
collettiva e senza scopo di lucro; l'Utente è inoltre responsabile per qualsiasi uso non autorizzato
dell'Abbonamento e
dei suoi contenuti, ove riconducibile all'account dell'Utente medesimo; per questo motivo l'Utente si
impegna ad
assumere tutte le precauzioni necessarie per mantenere riservato l'accesso all'Abbonamento attraverso il
proprio account
(per esempio, mantenendo riservate le credenziali di accesso ovvero segnalando senza ritardo al Fornitore
che la
riservatezza di tali credenziali risulta compromessa per qualsiasi motivo).
7.4 La violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo conferisce al Fornitore il diritto di
risolvere
immediatamente il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, fatto salvo il risarcimento dei
danni.
8. Tutela della proprietà intellettuale e industriale
8.1 L'Utente riconosce e accetta che i contenuti dell'Abbonamento, sotto forma di testi, immagini,
fotografie, grafiche,
disegni, contenuti audio e video, animazioni, marchi, loghi e altri segni distintivi, sono coperti da
copyright e dagli
altri diritti di proprietà intellettuale e industriale di volta in volta facenti capo al Fornitore e ai suoi
danti causa
e per questo si impegna a rispettare tali diritti.
8.2 Tutti i diritti sono riservati in capo ai titolari; l'Utente accetta che l'unico diritto acquisito con
il contratto
è quello di fruire dei contenuti dell'Abbonamento con le modalità e i limiti propri del Servizio. Fatte
salve le
operazioni di archiviazione e condivisione consentite dalle apposite funzionalità del Servizio, qualsiasi
attività di
riproduzione, pubblica esecuzione, comunicazione a terzi, messa a disposizione, diffusione, modifica ed
elaborazione dei
contenuti è espressamente vietata.
8.3 La violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo conferisce al Fornitore il diritto di
risolvere
immediatamente il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, fatto salvo il risarcimento dei
danni.
9. Manleva
9.1 L'Utente si impegna a manlevare e tenere indenne il Fornitore contro qualsiasi costo – inclusi gli
onorari degli
avvocati, spesa o danno addebitato al Fornitore o in cui il Fornitore dovesse comunque incorrere in
conseguenza di usi
impropri del Servizio da parte dell'Utente o per la violazione da parte di quest'ultimo di obblighi
derivanti dalla
legge ovvero dai presenti termini d'uso.
10. Limitazione di responsabilità
10.1 Il Fornitore è impegnato a fornire un Servizio con contenuti professionali e di alta qualità; tuttavia,
il
Fornitore non garantisce all'Utente che i contenuti siano sempre privi di errori o imprecisioni; per tale
motivo,
l'Utente è l'unico responsabile dell'uso dei contenuti e delle informazioni veicolate attraverso di
essi.
10.2 L'Utente riconosce e accetta che, data la natura del Servizio e come da prassi nel settore dei servizi
della
società dell'informazione, il Fornitore potrà effettuare interventi periodici sui propri sistemi per
garantire o
migliorare l'efficienza e la sicurezza del Servizio; tali interventi potrebbero comportare il rallentamento
o
l'interruzione del Servizio. Il Fornitore si impegna a contenere i periodi di interruzione o rallentamento
nel minore
tempo possibile e nelle fasce orarie in cui generalmente vi è minore disagio per gli Utenti. Ove
l'interruzione del
Servizio si protragga per oltre 24 ore, l'Utente avrà diritto a un'estensione dell'Abbonamento per un numero
di giorni
pari a quello dell'interruzione; in tali casi, l'Utente riconosce che l'estensione dell'Abbonamento è
l'unico rimedio in
suo favore, con la conseguente rinunzia a far valere qualsivoglia altra pretesa nei confronti del
Fornitore.
10.3 L'Utente riconosce e accetta che nessuna responsabilità è imputabile al Fornitore:
- per disservizi dell'Abbonamento derivanti da malfunzionamenti di reti elettriche e telefoniche ovvero di
ulteriori
servizi gestiti da terze parti che esulano del tutto dalla sfera di controllo e responsabilità del Fornitore
(per
esempio, disservizi della banca dell'Utente, etc...);
- per la mancata pubblicazione di contenuti editoriali che derivi da cause di forza maggiore.
10.4 In tutti gli altri casi, l'Utente riconosce che la responsabilità del Fornitore in forza del contratto
è limitata
alle sole ipotesi di dolo o colpa grave.
10.5 Ai fini dell'accertamento di eventuali disservizi, l'Utente accetta che faranno fede le risultanze dei
sistemi
informatici del Fornitore.
11. Modifica dei termini d'uso
11.1 L'Abbonamento è disciplinato dai termini d'uso approvati al momento dell'acquisto.
11.2 Durante il periodo di validità del contratto, il Fornitore si riserva di modificare i termini della
fornitura per
giustificati motivi connessi alla necessità di adeguarsi a modifiche normative o obblighi di legge, alle
mutate
condizioni del mercato di riferimento ovvero all'attuazione di piani aziendali con ricadute sull'offerta dei
contenuti.
11.3 I nuovi termini d'uso saranno comunicati all'Utente con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla
scadenza del
periodo di fatturazione in corso ed entreranno in vigore a partire dall'inizio del periodo di fatturazione
successivo.
Se l'Utente non è d'accordo con i nuovi termini d'uso, può esercitare la disdetta secondo quanto previsto al
precedente
articolo 3.
11.4 Ove la modifica dei termini d'uso sia connessa alla necessità di adeguarsi a un obbligo di legge, i
nuovi termini
d'uso potranno entrare in vigore immediatamente al momento della comunicazione; resta inteso che, solo in
tale ipotesi,
l'Utente potrà recedere dal contratto entro i successivi 30 giorni, con il conseguente diritto ad ottenere
un rimborso
proporzionale al periodo di abbonamento non goduto.
12. Trattamento dei dati personali
12.1 In conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679 UE e dal Codice della privacy (decreto
legislativo 30
giugno 2003, n. 196), i dati personali degli Utenti saranno trattati per le finalità e in forza delle basi
giuridiche
indicate nella privacy policy messa a disposizione dell'Utente in sede di registrazione e acquisto.
12.2 Accettando i presenti termini di utilizzo, l'Utente conferma di aver preso visione della privacy policy
messa a
disposizione dal Fornitore e di averne conservato copia su supporto durevole.
12.3 Il Fornitore si riserva di modificare in qualsiasi momento la propria privacy policy nel rispetto dei
diritti degli
Utenti, dandone notizia a questi ultimi con mezzi adeguati e proporzionati allo scopo.
13. Servizio clienti
13.1 Per informazioni sul Servizio e per qualsiasi problematica connessa con la fruizione dello stesso,
l'Utente può
contattare il Fornitore attraverso i seguenti recapiti: help@newslist.it
14. Legge applicabile e foro competente
14.1 Il contratto tra il Fornitore e l'Utente è regolato dal diritto italiano.
14.2 Ove l'Utente sia qualificabile come consumatore, per le controversie comunque connesse con la
formazione,
esecuzione, interpretazione e cessazione del contratto, sarà competente il giudice del luogo di residenza o
domicilio
del consumatore, se ubicato in Italia.



